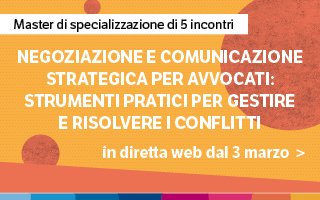La valutazione della responsabilità dell’amministratore di una società in caso di bancarotta fraudolenta da reato societario e operazioni dolose
di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge Scarica in PDFCass. pen., Sez. V, Sent., 21/02/2025, n. 7261
Parole chiave: bancarotta fraudolenta impropria da reato societario per false comunicazioni sociali – bancarotta preferenziale – bancarotta impropria da operazioni dolose – fraudolento autofinanziamento – fallimento.
Massima: “Nella valutazione della responsabilità per bancarotta fraudolenta da reato societario e operazioni dolose, è essenziale accertare il nesso causale tra le condotte dell’imputato e il dissesto della società, distinguendo tra debiti preesistenti e quelli generati durante il periodo di gestione dell’imputato”.
Disposizioni applicate: art. 223, comma 2, n. 2, Legge Fallimentare – art. 217 Legge Fallimentare.
Il giudizio di Cassazione oggetto del presente commento muove dall’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la quale “A.A.”, amministratore unico e legale rappresentante della società CMP costruzioni S.r.l. – dichiarata fallita in data 6 agosto 2014 – veniva assolto dal reato di bancarotta da reato societario, veniva dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta preferenziale poichè prescritto, nonché venivano rideterminate le pene (principale ed accessoria fallimentare) per il residuo reato di bancarotta impropria da operazioni dolose.
Nel ritenere fondati, e tra loro connessi, solamente primi due motivi di gravame, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato quanto segue.
In primo luogo, la Corte adita, nel ripercorrere brevemente i fatti di causa, ha evidenziato che l’imputato ha acquisito l’incarico quando il profilo debitorio della società era già imponente e come non vi fosse alcuna possibilità di risanamento, tanto che la società era rimasta inattiva fin dal 2009, dopo la cessione del ramo di azienda costituente l’unico asset attivo della fallita, operazione peraltro portata avanti in un momento in cui il sig. “A.A.”non rivestiva, nella società, alcun ruolo gestorio.
Ebbene in tale contesto – ove, al momento dell’omissione del pagamento di tasse e di contributi da parte della CMP costruzioni S.r.l., la stessa era già impossibilità nell’esercitare la propria attività tipica e, dunque, di produrre reddito – la Cassazione ha ricordato come le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, Legge Fallimentare, possono sì consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, ma assumono rilievo penale in quanto esse siano il frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali.
Ed è proprio tale pianificazione da parte dell’imputato – sottolinea la Corte – che, nella fattispecie in esame, non è stata correttamente ricostruita dai Giudici di merito, i quali avrebbero dovuto spiegare come sia conciliabile la inattività della società e la conseguente assenza di reddito da produzione, con la strategia di fraudolento autofinanziamento sottesa alla scelta di omettere il pagamento delle imposte senza provvedere al relativo accantonamento.
In particolare, la Corte d’Appello non ha chiarito l’entità dello specifico contributo causale offerto dal “A.A.” all’aggravamento del dissesto. La Cassazione, in relazione al tema della prova necessaria per potere affermare la penale responsabilità dell’imputato, valutando l’effettivo ruolo causale svolto in ordine al dissesto della società che ne ha determinato il fallimento, ha ribadito che, nella bancarotta societaria per effetto delle operazioni dolose, l’affermazione di responsabilità dell’amministratore presuppone la prova dell’incidenza causale del suo ruolo gestorio rispetto al debito preesistente.
Per quanto concerne l’elemento psicologico del reato, invece, nella fattispecie delittuosa in esame, la Cassazione ha ricordato che il dissesto, quanto al dolo, è solo l’effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria avente ad oggetto l’operazione, e non è richiesta l’intenzionalità diretta a produrre il dissesto medesimo: è proprio questa la differenza fra le due fattispecie previste dall’art. 223, comma 2, n. 2) della Legge Fallimentare.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico.
In tale contesto, la sentenza impugnata dal ricorrente ha mancato, a parere della Corte, di scrutinare il suddetto elemento soggettivo del reato.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia