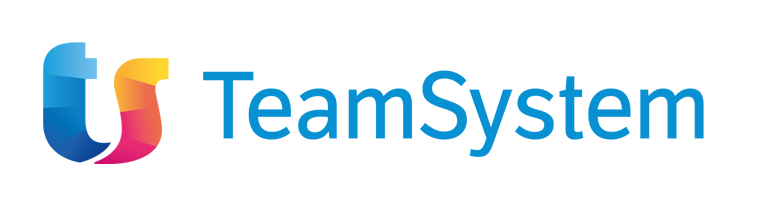Sul valore probatorio della sentenza di patteggiamento
di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDFE’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile (conclusione conforme agli approdi della dottrina processual penalistica, che da tempo sottolinea l’assenza di una vera e propria verifica della colpevolezza dell’imputato: Ferrua, Il giusto processo, Bologna, 2005, 77), contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2695; Cass., 31 marzo 2015, n. 6582; Cass., 18 aprile 2013, n. 9456; Cass., 6 dicembre 2011, n. 26263; Cass., 19 novembre 2007, n. 23906).
La stessa giurisprudenza precisa talvolta che la sentenza di patteggiamento “esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3980).
Le tre conclusioni – ossia i) la relevatio ab onere probandi, ii) l’onere di motivazione sulle ragioni per cui l’imputato avrebbe dovuto ammettere un’inesistente responsabilità e iii) l’onere di “ragionata sconfessione” del magistrato penale – si prestano ad alcune critiche, apparendo tutt’al più ultimi echi di quel principio di unità della giurisdizione che, come più volte sottolineato dalla Cassazione (Cass, 18 gennaio 2007, n. 1095; Cass., 25 marzo 2005, n. 6478; Cass., 1° luglio 2004, n. 12093), non trova più cittadinanza nell’ordinamento processuale italiano a far data dall’emanazione codice di procedura penale del 1988, che ha invece abbracciato il nuovo presupposto della separazione delle giurisdizioni, tale per cui il giudice, al di fuori delle ipotesi in cui opera il vincolo del giudicato penale, nel procedere ad un autonomo apprezzamento dei fatti rispetto a quello già operato in altra sede giurisdizionale non può ritenersi soggetto ad alcun particolare onere di motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto ad operare una diversa valutazione degli elementi probatori già emersi nell’istruttoria esperita in sede penale (Cass., 17 febbraio 2010, n. 3820; Cass., 23 maggio 1996, n. 4748).
In particolare, la conclusione sub i) non è armonica con la disciplina della confessione, in riferimento alla quale una granitica giurisprudenza richiede l’elemento soggettivo dell’animus confitendi (ossia la “volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte”: Cass., 9 aprile 2013, n. 8611) ed esclude che tale profilo sussista laddove, ad esempio, la dichiarazione sia stata effettuata dal datore di lavoro in un verbale ispettivo e dunque sia stata “resa in funzione degli scopi dell’inchiesta” (Cass., 7 settembre 2015, n. 17702).
Non si vede allora perché un effetto tanto dirompente, quale è quello derivante dall’esonero per la parte dalla dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa, dovrebbe essere riconosciuto ad una prova atipica, tanto più se evidentemente sprovvista di un elemento invece tradizionalmente richiesto per l’individuazione di una prova legale (tipica).
Le conclusioni sub ii) e iii) non parrebbero invece conciliarsi con l’efficacia persuasiva generalmente assegnata alla sentenza di patteggiamento, ossia quella di un “importante” elemento di prova (così la citata Cass., 2695/2017; Cass., 26 marzo 2012, n. 4804; Cass., 10 giugno 2011, n. 12763; Cass., 3 aprile 2009, n. 8127) o tutt’al più, come più frequentemente affermato dalla giurisprudenza di merito, di un argomento di prova (Trib. Firenze, 30 maggio 2011, in www.altalex.it, e Trib. Modena, 24 marzo 2011, in www.giurisprudenzamodenese.it).
Se dunque la sentenza ex artt. 444 s. c.p.p. rientra nell’ambito delle “prove” (nella forma debole dell’argomento o in quella più “importante” di prova liberamente valutabile, per usare l’espressione della giurisprudenza), sfugge la ragione sistematica per cui il suo superamento richieda una apposita motivazione: essa dovrebbe essere invece soggetta al pacifico orientamento in base al quale il giudice civile, nella ponderazione del valore da attribuirsi “ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro”, non è tenuto a “dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali”, dovendosi dare per “implicitamente disattesi” gli elementi probatori “morfologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass., 12 settembre 2011, n. 18644).
Tanto più che uno dei due oneri si pone in aperta contraddizione con una norma del codice di procedura penale.
E’ infatti assai problematica la conclusione sub iii), ossia la necessità di una ricostruzione dei motivi in base ai quali il magistrato penale ebbe a optare per l’emissione di una sentenza di condanna – sia pure nelle forme del patteggiamento – anziché per la dichiarazione d’ufficio della ricorrenza di uno dei casi di proscioglimento, indicati dall’art. 129 c.p.p. nelle ipotesi in cui il fatto “non sussiste” ovvero “l’imputato non lo ha commesso”, “non costituisce reato”, “non è previsto dalla legge come reato”, “è estinto” o, infine, è escluso dalla mancanza di una delle condizione di procedibilità previste dal Titolo III del Libro V del codice di procedura penale.
L’onere parrebbe contraddire il comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., che, nell’ottica di incentivazione dell’imputato alla rinuncia al diritto di difendersi in un pubblico dibattimento, nega espressamente alla sentenza di patteggiamento la (pur limitata) efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi invece riconosciuta alle sentenze definitive di condanna o di assoluzione ex artt. 651 s. c.p.p.: laddove, in altre parole, è lo stesso legislatore ad aver esplicitamente escluso che il giudice civile sia vincolato alle risultanze dell’accertamento, sembra superfluo assegnare all’estensore il compito di soffermarsi, in motivazione, sulle ragioni che lo hanno indotto a decidere in difformità dalla ricostruzione accolta dal magistrato penale nella sentenza emessa in applicazione della pena su richiesta di parte.
Quanto alle ragioni di chi patteggi la condanna per un reato mai commesso [onere sub ii)], il compito assegnato al giudice civile sembra invece impegnativo.
Il meccanismo premiale sotteso alla disciplina dei riti alternativi al processo penale ordinario, e del patteggiamento in particolare, si fonda sull’allestimento di veri e propri incentivi che possono ragionevolmente indurre l’imputato innocente – ma consapevole della difficoltà di dimostrare in dibattimento la propria innocenza – ad accettare una decisione “allo stato degli atti” come contropartita di una pena magari contenuta nei minimi edittali: tra questi incentivi, si consideri l’immediata interruzione di quella che la dottrina processual penalistica definisce la “pena anticipata” rappresentata dalla partecipazione in sé al processo penale in qualità di imputato (in tal senso Iannaccone, I rapporti tra processo penale e procedimento tributario alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, in Fisco, 2008, 41, 7376); il compromesso di una sentenza che conserva le forme della condanna ma che, nella sensibilità e nell’opinione comuni, non contiene una constatazione incontrovertibile della responsabilità penale; e infine, come si è visto poco sopra, la garanzia dell’inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento a fini di prova nel giudizio civile sul risarcimento del danno.
Si osserva infine che l’utilità della ricostruzione dell’iter logico adottato dal magistrato penale sembra in ogni caso da limitare alle sole ipotesi, tra quelle considerate dall’art. 129 c.p.p. ai fini del proscioglimento dell’imputato, che risulterebbero astrattamente idonee ad offrire al giudice civile elementi di valutazione sulla fondatezza della domanda formulata dall’attore nel giudizio civile, ossia gli accertamenti vòlti a stabilire se “il fatto non sussiste” o (salvo i casi di eccezionale responsabilità per fatto altrui: v. ad. es. le ipotesi disciplinate dagli artt. 2047, 2048, 2049, 2054 comma 3 c.c., nelle quali l’ipotetica verifica giudiziale che l’imputato “non ha commesso il fatto” non esclude di per sé la possibile responsabilità civile dello stesso soggetto per il fatto commesso da altri) “l’imputato non lo ha commesso”.
La stessa idoneità deve invece essere esclusa per le statuizioni con cui il giudice penale dichiari che “il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato” (stante la possibile configurazione delle medesime condotte, come ad esempio quelle di danneggiamento colposo, alla stregua di illeciti civili) o ancora che “il reato è estinto” (ben potendo la condotta l’illecito penale ormai prescritto aver creato, in capo al danneggiato, un diritto al risarcimento del danno ancora azionabile in sede civile) o che “manca una condizione di procedibilità”: si pensi, a quest’ultimo proposito, all’omessa presentazione della querela, anch’essa circostanza irrilevante ai fini della decisione del giudice civile sulla fondatezza della pretesa dell’attore – già persona offesa dal reato – all’ottenimento del risarcimento del danno cagionato dalla condotta del convenuto.
Si segnala infine che la L. 27 marzo 2001, n. 97 la quale, in deroga al principio dell’autonomia tra giurisdizioni, ha previsto che nel giudizio disciplinare la sentenza di patteggiamento sia equiparata alla sentenza di condanna e che la sentenza penale irrevocabile di condanna abbia “efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, al fine (rilevato in dottrina da Dominici, La “‘valenza indiziaria” del patteggiamento nel giudizio disciplinare del dipendente pubblico, in Giur. it., 2015, I, 1383) “di dare credibilità alla pubblica amministrazione favorendo la coerenza tra la decisione penale e la pronuncia in sede civile qualora l’imputato, soggetto alla sanzione disciplinare, abbia patteggiato la pena per il medesimo fatto oggetto di accertamento nel giudizio civile”.