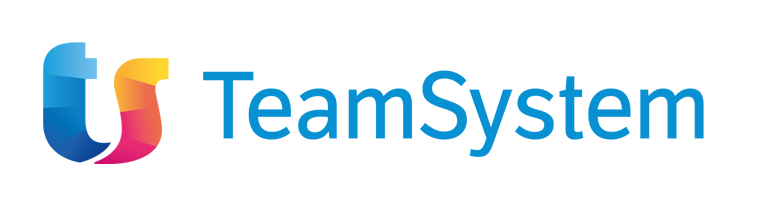Sull’interpretazione del requisito dell’ ‘esposizione sommaria dei fatti di causa’ di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c.
di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF- Il problema della “sommarietà”.
Come è noto, l’art. 366, n. 3, c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione contenga una «esposizione sommaria dei fatti di causa».
Il nodo problematico della disposizione – il cui generico tenore letterale ha generato un’ampia letteratura (Carpi, La tecnica di formazione del ricorso per Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 1017 ss.; Chiarloni, Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l’inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza, in www.judicium.it; Giusti, L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile, in Giust. civ., 2013, I, 247 ss.; Poli, Il giudizio di cassazione dopo la riforma, in Riv. dir. proc., 2007, I, 15; Ricci E.F., Sull’“autosufficienza” del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l’avvocato cassazionista come amanuense, in Riv. dir. proc., 2010, I, 736 ss.; Ricci G.F., Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2013, 273 s.; Russo, Sull’ ‘esposizione sommaria dei fatti della causa’ nel ricorso per cassazione, in Nuova Giur. civ. comm., 2008, I, 381 ss.; Sassani, Il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 2006, 217 ss.; Santangeli, Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, I, 608; Tiscini, Il giudizio di cassazione riformato, in Giusto proc. civ., 2007, 523 ss.) oltre, come si vedrà, un’incessante elaborazione della giurisprudenza, che vi ha visto uno dei terreni elettivi per l’applicazione del principio di autosufficienza, per cui la semplice lettura del ricorso deve evidenziare «tutti gli elementi necessari al giudice di legittimità per avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti, ed atti del processo» (Cass., 31 maggio 2016, n. 11269; Cass., 22 febbraio 2016, n. 3439; Cass., 14.2.2011, n. 3596) – attiene all’interpretazione del requisito della “sommarietà”.
Il tema è reso di vivo interesse per gli operatori alla luce della grave sanzione cui il codice riconduce la violazione del requisito sia per difetto che per eccesso: la scure dell’inammissibilità (e la conseguente formazione del giudicato sulla sentenza impugnata) si abbatte infatti non soltanto sul ricorso che radicalmente ometta di dar conto, o dia insufficientemente conto, dei «fatti di causa», ma – secondo l’orientamento ancora recentemente ribadito dalla Cassazione con la discussa sentenza n. 18962 del 2017, che si vedrà più approfonditamente infra – anche nel caso opposto, in cui il ricorrente ecceda nello spazio dedicato all’esposizione così privando la narrazione dei fatti sostanziali e processuali del carattere di “sommarietà”.
- Il difetto dell’esposizione.
Procedendo con ordine, l’esame della vasta produzione giurisprudenziale sul concetto di esaustività dell’esposizione dei fatti di causa evidenzia la netta prevalenza di provvedimenti che affrontano il tema per negare nel caso specifico la sufficienza dell’esposizione: al contrario la Corte, quando ritiene che le modalità di redazione del ricorso rispettino il principio di autosufficienza, difficilmente motiva le ragioni che hanno indotto il collegio a ritenere integrati gli estremi di una “sommaria” (ma sufficiente) rievocazione, e ciò si riflette in un’oggettiva difficoltà di rinvenire precedenti che contribuiscano ad arricchire di contenuti la scarna espressione utilizzata dalla norma.
In positivo la Cassazione chiede una «sintesi funzionale» (Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698) o almeno ad una «attività di narrazione» (purché «non brevissima»: Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628) del contenuto degli atti dei giudizi di merito, tale per cui l’esposizione, per raggiungere almeno lo standard della sommarietà, evidenzi con sufficiente chiarezza sia i fatti sostanziali, ossia i fatti su cui si fondano le pretese delle parti, sia quelli processuali, ossia la sintesi dello svolgimento dei gradi di merito (Cass., 12 novembre 2014, n. 24163), quantunque non si imponga che tale narrativa costituisca una premessa autonoma e graficamente distinta rispetto ai motivi di ricorso, e anzi risultando «sufficiente ed, insieme, indispensabile» che «dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del ‘fatto’» (Cass., 5 maggio 2009, n. 10288; Cass., 17 maggio 2007, n. 11433; Cass,, 3 febbraio 2004, n. 1959).
Altra giurisprudenza procede ad un più analitico elenco degli elementi che devono necessariamente caratterizzare l’esposizione, ossia l’allegazione, «chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata», dei «fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria», lo «svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni», le «argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito» (Cass., 31 luglio 2017, n. 18949; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass., 4 aprile 2006, n. 7825).
Ciò, in vista essenzialmente di due scopi: permettere alla Corte di «percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso» (Cass., 20 giugno 2017, n. 15342; Cass., 17 giugno 2016, n. 12525; Cass., 11 gennaio 2013, n. 593, tutte e tre soltanto in motivazione; in dottrina, sul profilo funzionale dell’art. 366, n. 3 c.p.c., v. G.F. Ricci, op. cit., 273 s., per cui la ricostruzione «non deve essere lunga e diffusa, così da fuorviare la Corte dal punto centrale della controversia, ma deve essere funzionale alla percezione dei singoli vizi», in ciò differenziandosi dal requisito di cui al successivo n. 4 dello stesso art. 366 c.p.c. dato che «mentre con i motivi di ricorso si enunciano i vizi della decisione dal punto di vista statico e se ne fa la critica, l’enunciazione dei fatti serve ad individuare i singoli vizi dal punto di vista dinamico e ciò quando si sono formati e come si sono formati»), e «valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno» (Cass., 19 gennaio 2017, n. 1296), ossia se il singolo motivo d’impugnazione investa un tema spendibile in quanto non precluso dalla formazione del giudicato interno per mancata impugnazione, in sede d’appello, del capo della sentenza di primo grado su cui il ricorrente già era risultato soccombente.
- L’eccesso nell’esposizione.
Non costituisce per il ricorrente un approdo maggiormente sicuro percorrere la strada opposta, ossia adottare un elevato grado di analiticità nella ricostruzione dei «fatti di causa»: soltanto in apparenza è operazione più prudente quella, per utilizzare una felice immagine della dottrina, di ispirarsi alla figura del «cassazionista come amanuense» (E.F. Ricci, op. cit., 736), che pure alcune pronunce sempre in materia di art. 366, n. 6, c.p.c. (che richiede la «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda») parrebbero obiettivamente imporre: si pensi che, sul fronte opposto, la Corte onera il ricorrente di procedere alla «trascrizione integrale» dei documenti rilevanti (Cass., 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., 28 giugno 2012, n. 10850), «dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative» (Cass., 11 agosto 2001, n. 10484), in ciò offrendo un’interpretazione giustamente criticata dalla stessa dottrina secondo cui indebitamente «la nostra Corte ricava dalla norma un generale principio di ‘autosufficienza’ del ricorso, in virtù del quale la ‘indicazione’ diventa ‘trascrizione’» (E.F. Ricci, op. cit., 737).
Da un lato è ormai consolidata infatti la giurisprudenza che esclude il rispetto dell’art. 366, n. 3, c.p.c. nell’attività di c.d. spillatura o assemblaggio, ossia la riproduzione meccanica (tramite mera trascrizione) o informatica (tramite scansione integrale) degli atti e documenti dei giudizi di merito (Cass., 11 aprile 2012, n. 5698; Cass., 17 luglio 2009, n. 16628).
In quest’ultima la Corte – pur precisando che la fotoriproduzione non comporta di per sé l’inammissibilità, dovendo comunque valutare il collegio se dalla lettura degli stralci degli atti e documenti inseriti graficamente nel testo del ricorso, è possibile arguire sinteticamente il fatto sostanziale e processuale (Cass., 17 maggio 2017, n. 12415) – condivisibilmente ravvede un non consentito autoesonero del ricorrente dal compito di evidenziare al giudice di legittimità «quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso» cui consegue, sostanzialmente, l’affidamento al collegio del compito di «leggere tutto», ivi compreso «quello di cui non occorre sia informata» (da ultimo Cass., 12 settembre 2017, n. 21136; Cass., 3 luglio 2017, n. 16341; di «flash-back processuale» tratta Cass., 23 giugno 2010, n. 15180, secondo cui il principio di autosufficienza «non può ritenersi rispettato quando venga adottata la tecnica della ‘spillatura’ degli atti, imponendosi che il ricorso, nel denunciare un vizio di legittimità, rappresenti le questioni con la tecnica del flash-back processuale, la quale presuppone l’espianto della questione stessa dal suo contesto, al fine di certificarne il carattere di non novità»).
Meno condivisibile, almeno nelle sue manifestazioni più esasperate, è invece l’applicazione del principio di autosufficienza resa dalla Cassazione per sancire lo stesso effetto di inammissibilità nei riguardi degli atti introduttivi la cui narrativa (e dunque non la materiale trascrizione o riproduzione per immagine degli atti di causa) ecceda l’ambiguo criterio della “sommarietà”.
Tanto più quando il suo superamento viene individuato sulla base del riferimento al numero di pagine dedicate dal ricorrente all’esposizione, e dunque in virtù di un parametro meramente “quantitativo” che mal si adatta non soltanto alle peculiarità del giudizio di legittimità, ma anche, e soprattutto, alle singole caratteristiche del caso concreto, tra cui l’oggettiva complessità dei fatti nel caso in cui, ad esempio, l’impugnazione prospetti questioni esaminate e, ipoteticamente, decise diversamente nei due gradi di merito (o, ulteriormente “complicando” l’ipotesi, nei quattro precedenti gradi, immaginando che la vicenda torni all’attenzione della Corte dopo un primo passaggio concluso con il rinvio al giudice d’appello, seguito da ricorso per cassazione avverso la nuova sentenza).
È poi da osservarsi che la lettura delle motivazioni delle decisioni che si sono soffermate sulle dimensioni dei ricorsi dichiarati inammissibili non permette di affermare con certezza che, dietro l’esternazione dei riferimenti “ponderali” delle esposizioni ritenute non sommarie, vi sia un criterio uniforme da parte della Cassazione: in altra occasione infatti la Corte ha lamentato che la trascrizione estesa su «quattordici pagine» delle difese esperite nei gradi di merito comportasse una strutturale «inidoneità» (addirittura «assoluta») della rievocazione a superare il vaglio di “sommarietà” imposto dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c. (Cass., 9 settembre 2010, n. 19255).
Se si eccettuano dunque le ipotesi in cui le stesse dimensioni monstre dell’esposizione evidenziano l’astensione del ricorrente persino dal tentativo di rispettare il requisito della sommarietà (è il caso deciso da Cass., 8 novembre 2012, n. 19357, che ravvisò la violazione dell’art. 366, n. 3 c.p.c. in un ricorso che la cui pedissequa riproduzione delle difese esperite nei precedenti gradi di giudizio raggiungeva le trecentodiciannove pagine, su un’estensione complessiva del ricorso di trecentoquaranta), appare assai poco convincente l’indirizzo della Corte per cui la (ritenuta) prolissità del ricorrente conduce tout court all’inammissibilità dell’impugnazione.
A tale conclusione è giunta la recente Cass., 31 luglio 2017, n. 18962, che – sulla base di un’implicita lettura della norma per cui il codice non si limiterebbe a chiedere un’esposizione almeno sommaria, ma precluderebbe l’esame nel merito anche ai ricorsi che contengano un’esposizione più che sommaria – ha dichiarato l’inammissibilità di tutti e nove i motivi proposti dal ricorrente rilevando l’eccessività di «ben cinquantuno pagine per spiegare l’intero svolgimento dei gradi di merito», che escluderebbero di per sé la sommarietà nella misura in cui rendono «particolarmente ‘indaginosa’ l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere» (l’aulica espressione “indaginosa” è stata utilizzata per la prima volta, ai fini che ci occupano, da Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628 e da allora ricorre frequentemente nella giurisprudenza di legittimità: solo negli ultimi mesi v. Cass., 8 settembre 2017, n. 20953; Cass., 11 agosto 2017, n. 20044; Cass., 28 luglio 2017, n. 18887).