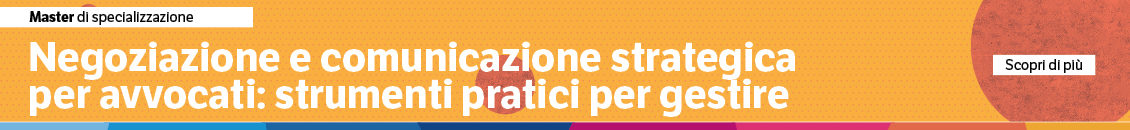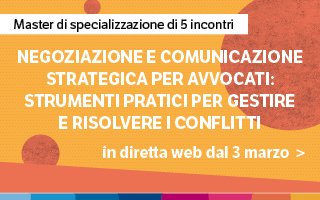Deduzione in cassazione del vizio di omessa pronuncia richiede un’esposizione chiara e puntuale della domanda o eccezione non decisa
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. II, 13 maggio 2025, n. 12695, Pres. ed Est. Mocci
Massima: “La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano state puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all’onere di indicarli precisamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.”
CASO
Il comproprietario di un fondo conveniva in giudizio l’altro comproprietario per sentire accertare l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale in favore del fondo medesimo e a carico dell’appezzamento antistante il confinante fabbricato di proprietà del convenuto. L’attore avanzava, nel dettaglio, sia una domanda di confessoria servitutis rispetto al tracciato, sia una domanda di negatoria servitutis rispetto agli spazi di pertinenza del fabbricato del convenuto.
Il Tribunale di Belluno rigettò entrambe le domande attoree.
L’adita Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame proposto, e in riforma della sentenza di primo grado condannò il convenuto alla cessazione di qualunque impedimento o turbativa all’esercizio della servitù di passaggio. I giudici di secondo grado, essendo incontestata l’esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo in comproprietà tra le parti, accolsero dunque la domanda di confessoria servitutis limitatamente agli aspetti accertativi e ripristinatori.
Avverso tale sentenza, l’attore proponeva ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse nella presente sede, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c. per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello completamente pretermesso l’esame della domanda di negatoria servitutis specificatamente svolta.
SOLUZIONE
[1] La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso proposto.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il ricorrente avrebbe puntualmente riportato nel ricorso per cassazione la domanda di negatoria servitutis proposta in sede di appello. Inoltre, tale domanda è stata, altresì, pedissequamente riprodotta nella sentenza gravata: ciò nonostante, il giudice di secondo grado ha totalmente mancato di prendere in considerazione anche tale istanza, derivandone così la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
All’accoglimento di tale motivo di ricorso è seguita pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato per un nuovo esame della domanda di negatoria servitutis.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alla configurazione del vizio di omessa pronuncia (in particolare, all’esito del giudizio di appello), e alle corrette modalità di deduzione dello stesso in cassazione.
Per quanto concerne il primo aspetto, è opportuno ricordare come l’omissione di pronuncia sia integrata da una violazione della regola, di c.d. corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posta dall’art. 112 c.p.c., secondo il quale «Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda […]». In altri termini, l’ordinamento pone in capo al giudicante un potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda giudiziale proposta dalla parte, ossia sulla richiesta di tutela giurisdizionale di una determinata situazione sostanziale dalla stessa avanzata (sull’istituto dell’omessa pronuncia si vedano i classici lavori di B. Lasagno, Premesse per uno studio sull’omissione di pronuncia nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1990; C. Calvosa, Omissione di pronuncia e cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1950; F. Carnelutti, Effetti della cassazione per omessa pronunzia, in Riv. dir. proc. civ., 1938; G. Cristofolini, Omissione di pronunzia, in Riv. dir. proc. civ., 1938).
Se tale definizione certamente si attaglia al giudizio di cognizione di primo grado, occorre però definire quando il giudice di seconde cure incorra in tale vizio, in considerazione del fatto che (almeno direttamente), lo stesso non si pronuncia sulla domanda giudiziale proposta dalla parte, bensì sui motivi d’appello dalla stessa proposti.
In effetti, la communis opinio sul tema ravvisa omissione di pronuncia all’esito del procedimento di secondo grado nel caso in cui il giudice manchi di pronunciarsi su uno o più motivi d’appello (Cass., 7 giugno 2023, n. 16028; Cass., 13 ottobre 2022, n. 29952; Cass., 9 giugno 2022, n. 18697). L’approccio che appare preferibile è quello di muovere dalla natura dell’appello il quale, come noto, è da riguardarsi come mezzo di impugnazione avente natura sostitutiva, ossia diretto a ottenere dal giudice superiore una nuova decisione che, all’esito del riesame, nei limiti delle questioni specificamente devolute, della domanda proposta in prime cure, si sostituisca alla sentenza impugnata. In altri termini, in virtù dell’effetto sostitutivo proprio dell’appello, la nuova pronuncia, che verte sul medesimo oggetto della decisione resa in primo grado, implica la rimozione di quest’ultima dal mondo giuridico (in tale senso, per tutti, A. Tedoldi, Natura dell’appello. Provvedimenti appellabili. Appello avverso le sentenze non definitive, in A. Tedoldi (diretto da), Le impugnazioni civili, Bologna, 2019, 301). Indice normativo comprovante la natura sostitutiva dell’appello sarebbe peraltro rappresentato dall’art. 393 c.p.c., nella parte in cui ricollega all’estinzione del giudizio di rinvio l’estinzione dell’intero processo, senza prevedere alcuna reviviscenza della pronuncia di primo grado per effetto dell’intervenuto annullamento di quella d’appello. Dunque, se il giudice d’appello deve pronunciarsi sul medesimo oggetto già dedotto in primo grado, possiamo affermare come il dovere decisorio del giudice di seconde cure si estenda, in effetti, sulla medesima domanda giudiziale già conosciuta e decisa all’esito del precedente grado di giudizio: di talché, l’espressione «domanda» di cui all’art. 112 c.p.c. mantiene, nel processo d’appello, lo stesso significato che assume in relazione al giudizio di cognizione di primo grado.
Per quanto riguarda le modalità di deduzione in cassazione del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello (il quale, dunque, abbia mancato di pronunciarsi sulla domanda giudiziale ad esso devoluta dalla parte appellante), il principio di autosufficienza notoriamente vigente in materia appare destinato a declinarsi in maniera del tutto particolare.
Tale principio, come noto, richiede che il ricorso contenga in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa, così consentendo l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, delle ragioni per cui si chiede la cassazione della pronuncia di merito e della fondatezza di tali ragioni (tra le tante, Cass., 29 marzo 2022, n. 10017; Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., 28 dicembre 2017, n. 31082; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass., 6 novembre 2006, n. 23673; Cass., 4 aprile 2006, n. 7825).
In punto di autosufficienza del ricorso denunciante il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello, la giurisprudenza di legittimità, più precisamente, richiede al ricorrente di allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di merito, riportando e trascrivendo puntualmente tali istanze, nei loro esatti termini (e non genericamente né mediante riassunto del loro contenuto) e di indicare in quale atto del giudizio di seconde cure lo abbia fatto – sì da consentire alla Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione -, non essendo legittimata, la Suprema Corte, a procedere a una loro autonoma ricerca, bensì soltanto alla verifica appena descritta (solo tra le più recenti, Cass., 7 marzo 2024, n. 6127; Cass., 13 giugno 2023, n. 16899; Cass., 31 maggio 2022, n. 17570; Cass., 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367). In altri termini, il ricorso deve essere redatto in modo tale che dallo stesso emerga, chiaramente e compiutamente, e senza necessità di far ricorso ad altri atti del processo, la richiesta di tutela avanzata dalla parte, con l’indicazione dell’atto difensivo nel quale tale richiesta era stata formulata.
Ne discende, come si diceva, una declinazione del principio di autosufficienza del ricorso del tutto particolare, nella misura in cui la stessa Cassazione, fanatica sostenitrice della sacralità di tale principio, si limita a richiedere al ricorrente di dimostrare l’avvenuta proposizione della domanda (poi rimasta non decisa), senza altresì pretendere – discostandosi, in ciò, dalle costanti affermazioni in tema di autosufficienza – l’indicazione dell’oggetto della censura avanzata contro la sentenza di secondo grado (ossia, dell’omissione compiuta dal giudice).
A ben vedere si tratta, peraltro, di limitazione intrinseca all’operatività del principio di autosufficienza del ricorso in materia di omessa pronuncia, più che di mitigazione del rigorismo tipico della Cassazione: nel momento in cui la parte denuncia davanti alla Suprema Corte il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello, infatti, giocoforza manca l’oggetto della censura specificamente rivolta alla sentenza di merito, in quanto consistente non in una decisione, bensì in una omissione. In altri termini, non si tratta, nella fattispecie in esame, di censurare quanto il giudice di merito ha pronunciato (ossia, una decisione), bensì di censurare la stessa circostanza per cui il giudice non ha pronunciato (ossia, una omissione): il che, appare sostanzialmente impossibile da dimostrare. Sembra dunque possibile affermare che in punto di censura, in cassazione, dell’omessa pronuncia commessa dal giudice d’appello, il principio di autosufficienza del ricorso trovi limiti intrinseci alla sua ordinaria operatività, nella misura in cui non appare possibile richiedere al ricorrente di dimostrare che il giudice ha omesso di pronunciare, non essendo possibile, più semplicemente, dimostrare l’esistenza di qualcosa che manca. In altri termini, ciò che la Cassazione pretende dal ricorrente è il massimo che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, la stessa possa pretendere, trattandosi nel caso di specie di offrire la dimostrazione di un fatto negativo.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia