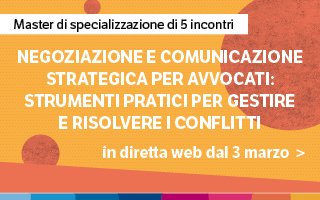La dichiarazione di fallimento determina la risoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti per impossibilità sopravvenuta
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 – Pres. Cristiano – Rel. Pazzi
Parole chiave: Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Successiva dichiarazione di fallimento – Impossibilità di attuazione del piano di risanamento – Sussistenza – Risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta – Conseguenze
[1] Massima: “In tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., la dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione dell’accordo fa sì che l’attuazione del piano sia resa impossibile per l’intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venire meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e la riespansione dell’originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.”
Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 67, 182-bis; cod. civ., art. 1463
CASO
Dichiarato il fallimento di una società, il creditore che aveva con questa stipulato un accordo di ristrutturazione del debito omologato ai sensi dell’art. 182-bis l.fall. presentava istanza di ammissione al passivo.
Il giudice delegato accoglieva la domanda, ma limitatamente alla somma che la società fallita aveva offerto di pagare in forza del predetto accordo.
L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 l.fall. era respinta dal Tribunale di Napoli, secondo il quale la dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, pur determinandone l’impossibilità di esecuzione, non provoca l’automatico scioglimento di tutti i contratti conclusi per la sua attuazione, sicché, non essendo stata chiesta la risoluzione di quello stipulato ai sensi dell’art. 182-bis l.fall. prima della sentenza di fallimento, non poteva essere fatto valere l’originario credito nella sua totalità, in quanto l’accordo continuava a produrre i propri effetti giuridici sostanziali.
Il decreto di rigetto veniva impugnato con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la dichiarazione di fallimento, determinando la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano posto a base dell’accordo di ristrutturazione omologato, ne determina la risoluzione, sicché l’obbligazione del debitore si riespande nella sua originaria conformazione e legittima il creditore a chiedere l’ammissione al passivo dell’intero credito vantato, al netto dei (soli) pagamenti medio tempore intervenuti e non più revocabili.
QUESTIONI
[1] L’art. 182-bis l.fall. – introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in l. 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente sostituito dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 – reca la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che integra un negozio finalizzato al superamento della crisi in cui versa l’impresa (anche derogando al principio della par condicio creditorum) e, a tale scopo, può assumere svariati contenuti (tra gli altri, di pactum de non petendo, di remissione parziale del debito, di costituzione di garanzia, di concessione di nuova finanza).
L’accordo in parola, come affermato da una costante giurisprudenza, appartiene al novero degli istituti del diritto concorsuale: la sua disciplina, infatti, presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (sotto il profilo delle condizioni di ammissibilità, del deposito della domanda presso il tribunale competente, della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e della necessità di omologazione) e dispone, dall’altro lato, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea, l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione) che sono tipici dei procedimenti concorsuali.
Fermo restando ciò, nella disciplina fallimentare non si rinvengono disposizioni che contemplano la dichiarazione di risoluzione per inadempimento dell’accordo di ristrutturazione.
A tale lacuna non può sopperirsi facendo riferimento alle norme dettate in materia di concordato preventivo, non essendo ravvisabile il presupposto dell’eadem ratio che consenta di ricorrere all’applicazione analogica.
Come osservato dai giudici di legittimità, infatti, l’accordo di ristrutturazione, pur prevedendo la presentazione di un piano che deve individuare un termine per il suo completo adempimento, è istituto che non contempla la presenza di organi che, al pari del commissario giudiziale, siano deputati a presidiare la procedura e a sorvegliarne l’esecuzione, riferendo al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori; né è prescritta la periodica redazione di rapporti riepilogativi delle attività svolte (alla quale è invece tenuto il liquidatore), che indichino tutte le informazioni di rilievo del periodo di riferimento.
In questo contesto, il singolo creditore non è messo nelle condizioni di monitorare l’andamento delle attività di esecuzione del piano, di apprezzarne la rilevanza in termini di importanza in relazione all’eventuale inadempimento e di assumere, così, l’iniziativa volta a sollecitare la dichiarazione di risoluzione entro il termine di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento (com’è previsto, invece, in materia di concordato).
Inoltre, mentre la risoluzione del concordato ha l’obiettivo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza i limiti imposti in ambito concordatario, facendo venire meno l’effetto obbligatorio dell’omologa per tutti i titolari di crediti anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 l.fall., l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione non determina un effetto analogo, mancando, in relazione a tale istituto, una norma avente la medesima portata dell’art. 184, comma 1, l. fall.: nella procedura disciplinata dall’art. 182-bis l.fall., infatti, l’omologazione consente di sottrarre all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato, comporta la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione degli accordi e in funzione della domanda di omologazione dei medesimi (purché la prededuzione sia espressamente prevista nel provvedimento di omologa), assume rilievo ai fini della quantificazione del danno risarcibile a mente dell’art. 2486 c.c.
Per la Corte di cassazione, dunque, l’inadempimento dell’accordo di ristrutturazione da parte del debitore non comporta la necessità di addivenire alla risoluzione dell’intera procedura, giacché la falcidia consegue alla conclusione dell’accordo fra singolo creditore e debitore e non costituisce l’effetto generalizzato del provvedimento di omologa per tutti i creditori anteriori all’avvio della procedura (com’è a dirsi per il concordato preventivo).
In altre parole, perché la falcidia creditoria, che è ricollegata al singolo accordo, venga meno, non è necessario che l’intera procedura sia attinta da una pronuncia di risoluzione.
La dichiarazione di fallimento, di converso, privando il fallito della disponibilità dei suoi beni e comportando l’inefficacia dei pagamenti da lui eseguiti, impedisce l’adempimento dell’accordo di ristrutturazione concluso e posto a base della domanda di omologa ex art. 182-bis l.fall., la cui esecuzione diviene impossibile per il sopravvenire di un evento che, sovrapponendosi alla procedura concorsuale precedentemente avviata e omologata, la rende irrealizzabile.
L’apertura della procedura concorsuale maggiore rende impossibile l’attuazione dell’accordo posto alla base di quella di natura concordataria e, quindi, irrealizzabili le finalità di risanamento che ne costituiscono l’essenza.
Si determina, così, in via automatica e senza necessità di istanze o provvedimenti di sorta, il venire meno dell’accordo per sopravvenuta impossibilità giuridica della prestazione, ovvero la sua risoluzione, stante l’irrealizzabilità della causa di risanamento a esso sottesa, indipendentemente dal fatto che i creditori che avevano aderito all’accordo si siano avvalsi dei rimedi previsti dagli artt. 1453 e seguenti c.c.; all’effetto risolutivo consegue la riespansione dell’originaria obbligazione.
Peraltro, mentre con riguardo al concordato preventivo, l’art. 186, comma 3, l.fall. prescrive che la risoluzione – in conseguenza della domanda dei creditori o della dichiarazione di fallimento – deve intervenire entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (sicché, in sua assenza, la parziale inesigibilità dei crediti ricollegata alla loro falcidia diviene definitiva anche nell’ambito del fallimento successivamente intervenuto), non esiste un’analoga disposizione nell’ambito della disciplina degli accordi di ristrutturazione, sicché il sopravvenuto fallimento, rendendo sempre irrealizzabile il piano a essi sotteso, determina il definitivo venire meno dell’efficacia parzialmente remissoria allo stesso collegata.
Infine, i giudici di legittimità richiamano la disposizione recata dall’art. 67, comma 3, lett. e), l.fall., che sottrae alla revocatoria i pagamenti effettuati in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, con la conseguenza che, in caso di successivo fallimento, il creditore che abbia concluso l’accordo potrebbe non solo trattenere quanto già ricevuto in pagamento, ma anche insinuarsi per l’intera somma residua, analogamente a quanto avviene in caso di concordato, qualora il fallimento sia dichiarato allorquando è ancora possibile sollecitarne la risoluzione (a differenza di quanto è a dirsi nel caso in cui il termine di cui all’art. 186, comma 3, l.fall. sia scaduto, atteso che, in questo caso, l’inesigibilità parziale del credito assume il carattere della definitività).
La particolare disciplina prevista dall’art. 67, comma 3, lett. e), l.fall. trova la propria giustificazione nel favor espresso dal legislatore verso le procedure concorsuali minori, essendo diretta a incentivare i creditori a sostenere la scelta del debitore di utilizzare gli strumenti posti a sua disposizione per risolvere la situazione di crisi in cui venga a trovarsi.
Ne consegue che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento e determinatasi in via definitiva l’impossibilità di esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, che viene conseguentemente meno, l’efficacia parzialmente remissoria allo stesso collegata non può preservarsi, sicché il creditore ha diritto di essere ammesso al passivo per l’intero ammontare del proprio credito, detratti soltanto gli importi eventualmente incassati in virtù di pagamenti non suscettibili di revocatoria.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia