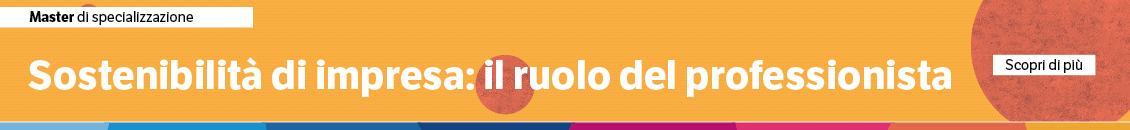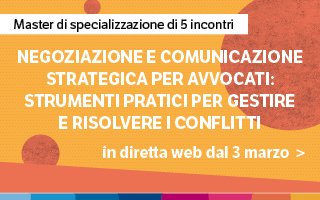Perizia stragiudiziale di parte non contestata: non si applica il principio di cui all’art. 115, 1°co., c.p.c.
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. III, 28 febbraio 2025, n. 5362, Pres. Scarano, Est. Graziosi
[1] Conclusioni di una perizia stragiudiziale di parte – Principio di non contestazione – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
Massima: “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza che aveva disatteso la richiesta di una delle parti, avanzata fin dal primo grado, di disporre una c.t.u. sul valore locativo di un immobile, in ragione della mancanza di specifiche censure alla sua quantificazione contenuta in una perizia di parte prodotta dalla parte avversa”). (massima ufficiale).
CASO
[1] Una s.r.l. stipulava con una società di leasing un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile sito in Roma. A causa dell’inadempimento dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni, la concedente si avvaleva della clausola risolutiva apposta al contratto e otteneva la riconsegna dell’immobile.
La s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Brescia la società di leasing per la restituzione dei canoni pagati (salvo il diritto della controparte al compenso per l’uso), trattandosi di leasing traslativo cui sarebbe stato applicabile l’art. 1526 c.c. La domanda veniva rigettata dal tribunale adito, che riteneva valida e applicabile la clausola del contratto secondo cui, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente avrebbe avuto diritto a chiedere il residuo credito, cioè i canoni scaduti non pagati fino alla data di risoluzione e i canoni da scadere a tale data nonché il valore di riscatto, detratto quanto ottenuto dalla ricollocazione sul mercato del bene.
Tale decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, la cui sentenza veniva conseguentemente fatta oggetto, dalla s.r.l. soccombente, di ricorso per cassazione. Lo stesso veniva articolato in due motivi, riguardanti l’applicazione, da parte dei giudici di merito, allo scopo di quantificare il valore dell’immobile, della mera perizia di parte – pur avendo la s.r.l. a tal fine richiesto la consulenza tecnica d’ufficio fin dal primo grado – senza aver adeguatamente motivato sul punto, e così giungendo a negare una riduzione della penale ex art. 1384 c.c. e a rigettare in toto la domanda. Nel dettaglio, parte ricorrente censurava: a) ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente calcolato la debenza a favore del concedente pervenendo a determinare, anche in base a “perizia prodotta dalla concedente in leasing non specificamente contestata”, la non sussistenza dei presupposti per la restituzione dei canoni versati né per una riduzione della penale ex art. 1384 c.c.; b) ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuta non provata la manifesta eccessività della penale aderendo in maniera acritica alla quantificazione dell’appellata avverso la quale la s.r.l., fin dal primo grado, aveva chiesto di effettuare consulenza tecnica d’ufficio in relazione al valore locativo.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ritiene fondati i motivi di ricorso proposti, conseguentemente cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa.
QUESTIONI
[1] La questione di diretto interesse ai fini del presente commento attiene all’idoneità delle risultanze della perizia stragiudiziale di parte, prodotta all’interno del giudizio, a rientrare nell’ambito applicativo del principio di non contestazione codificato nell’art. 115 c.p.c.: ciò è quanto, nel caso di specie, hanno ritenuto i giudici di merito, i quali, sulla base del valore attestato da una “perizia di parte non specificamente contestata” hanno escluso di dover procedere a quantificare il valore dell’immobile concesso in leasing e, conseguentemente, di dover rideterminare il valore della penale a norma dell’art. 1384 c.c.
In altri termini – fermo che, come noto, l’art. 1384 c.c. consente al giudice di diminuire equamente la penale «se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento» -, i giudici di merito hanno escluso l’esercizio di detto potere, non ritenendo la penale manifestamente eccessiva sulla base del valore del bene immobile concesso in leasing attestato da una perizia della parte concedente, non specificamente contestata dalla s.r.l. utilizzatrice (la quale, infatti, si era limitata a richiedere una c.t.u.).
Ora, il tema su cui occorre interrogarsi è, evidentemente, se le risultanze di una perizia stragiudiziale, prodotta dalla parte, possano effettivamente costituire l’oggetto dell’attività di non contestazione disciplinata dall’art. 115, 1°co., c.p.c. (secondo il quale, come altrettanto noto, «Il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita»).
Tale disposizione – che ha codificato, all’interno del nostro ordinamento, il c.d. principio di non contestazione – impone in capo al ciascuna parte un vero e proprio onere di contestazione dei fatti allegati dalla controparte, ricollegando all’attività di non contestazione un effetto di relevatio ab onere probandi del fatto ex adverso allegato ma non contestato, tale per cui lo stesso, anche se non provato, potrà comunque essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione (sul principio di non contestazione, senza pretese di completezza, A. Carratta, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995, passim; L.P. Comoglio, Fatti non contestati e poteri del giudice, in Riv. dir. proc., 2014, 1045 ss.; F. De Santis, Sul concetto di «non inequivocabilità» della non contestazione, in Riv. dir. proc., 2008, 560 ss.; I. Pagni, L’onere di contestazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell’art. 115 c.p.c., in Giur. it., 2011, V, 237 ss.; A. Proto Pisani, Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile, in Foro it., 2003, 604 ss.; A. Tedoldi, La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 76 ss.). Correlativamente, l’attività di contestazione è idonea a far confluire il fatto ex adverso allegato tra i fatti controversi, in quanto tali bisognosi di prova e interessati dalla regola di giudizio fondata sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., la quale implica che il fatto allegato, divenuto controverso in virtù dell’attività di contestazione svolta da controparte, e non provato, debba essere considerato dal giudice, in fase decisoria, come inesistente (sul principio dell’onere della prova, G. Verde, L’onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974, passim; M. Taruffo, voce Onere della prova, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., XIII, Torino, 1995, 65 ss.).
Ora, tornando al caso che ci occupa, le risultanze della perizia stragiudiziale prodotta dalla parte erano idonee ad assurgere a veri e propri fatti giuridici (principali), idonei a fondare l’onere di contestazione della controparte, con la conseguenza per cui, stante la non contestazione di questa, gli stessi potevano legittimamente essere posti dal giudice a fondamento della propria decisione?
La soluzione negativa raggiunta dalla Cassazione ci appare condivisibile.
Anzitutto è necessario chiarire che la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte è qualificabile come scrittura privata proveniente da terzi, trattandosi di scrittura prodotta in giudizio contro una parte che non appare esserne l’autore: come noto, l’efficacia probatoria da riconoscere alle stesse è conseguentemente assai problematica, rappresentando un classico esempio della controversa categoria delle prove c.d. atipiche (sul tema, M. Taruffo, Prove atipiche e convincimento del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, 410 ss.; G.F. Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, passim; B. Cavallone, Critica della teoria delle prove atipiche, in B. Cavallone, Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, 335 ss.; nello specifico, sulle scritture private provenienti da terzi, A. Ronco, Riflessioni sulla disciplina processuale e sull’efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi, in Riv. dir. civ., 1986, II, 553).
È proprio sulla base della loro collocazione tra le prove c.d. atipiche che alle scritture private provenienti da terzi (tra cui le perizie stragiudiziali prodotte dalla parte) viene usualmente riconosciuto un mero valore indiziario (in tal senso, Cass., 30 novembre 2010, n. 24208; con specifico riguardo alla perizia di parte, Cass., 5 giugno 1999, n. 5544; Cass., 19 maggio 1997, n. 4437).
V’è da dire, peraltro, che a partire dall’arresto di Cass., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13902, la perizia stragiudiziale viene generalmente qualificata quale mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (in tal senso, Cass., 30 novembre 2020, n. 27297; Cass., 24 agosto 2017, n. 20347; Cass., 6 agosto 2015, n. 16552).
Questo, in effetti, sembra essere l’indirizzo seguito anche dal provvedimento che si commenta, avendo affermato che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio”, costituendo piuttosto una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione”.
Nella prospettiva che ci interessa – ossia, sulla possibilità per la perizia stragiudiziale di formare oggetto di non contestazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c. -, però, nulla cambia: sulla base delle premesse poc’anzi chiarite, la decisione in epigrafe (evocando, nello specifico, Cass., 23 novembre 2022, n. 34450) conclude nel senso per cui quanto contenuto in una perizia stragiudiziale non possa formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non assurgendo a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituendo un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia