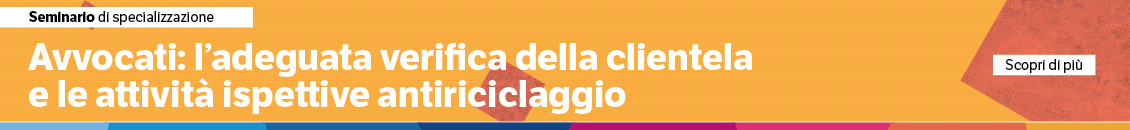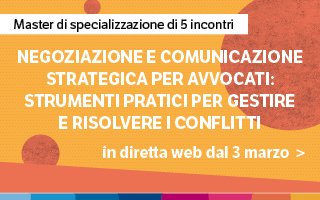L’accertamento della causa di servizio per i militari affetti da patologie oncologiche: parola all’adunanza plenaria
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFIl Consiglio di Stato, con due recenti ordinanze (nn. 3649 e 3650 del 29 aprile 2025), ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione del seguente quesito:
“quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, ed in particolare se essa postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se essa muova da una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”.
LA QUAESTIO IURIS
La questione controversa attiene alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio – ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – delle patologie di natura oncologica contratte da militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione di missioni all’estero o attività presso poligoni di tiro nazionali.
Tale fattispecie è oggetto di una disciplina concorrente: da un lato, quella “ordinaria” e generale in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo, dettata dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; dall’altro, quella riferita al personale militare italiano che “abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative” – tra cui rientrano, espressamente, “l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle prodotte da esplosione di materiale bellico” – di cui all’art. 603 c.m. (d.lgs. 15 marzo 2010, n., 66) e agli artt. 1078 e ss. t.m. (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), cui sono stati estesi i benefici previsti a favore delle c.d. “vittime del dovere” (in continuità con quanto già previsto dall’art. 1 comma 564, l. 23 dicembre 2005, n. 266).
Le due tipologie di erogazioni economiche, pur essendo accomunate dal fatto di conseguire al riconoscimento dell’origine professionale di una infermità o patologia, sono ricondotte a due differenti posizioni giuridiche soggettive e conosciute da due diverse giurisdizioni:
- Nell’ipotesi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo “ordinario” (ex d.P.R. 461/2001), la giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo, trattandosi di pretesa che trova «titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro», con conseguente devoluzione della controversia al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (Cass. civ., sez. un., ord. 12 aprile 2022, n. 11772; id., 24 marzo 2010, n. 6997; id, 15 luglio 2008, n. 19342) e quindi al giudice amministrativo quando si tratti di militari, forze di polizia e altre categorie in regime di diritto pubblico.
La giurisprudenza amministrativa ritiene, inoltre, che le controversie in materia di equo indennizzo individuino posizioni giuridiche di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2024, n. 10281; sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6305; sez. VI, 31 agosto 2018, n. 5132; sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4135), con conseguente impossibilità per il giudice di estendere il proprio sindacato al merito tecnico delle valutazioni medico-legali operate dell’amministrazione e inammissibilità di azioni (e conseguenti pronunce) dirette all’accertamento del nesso di dipendenza (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
- Diversamente, con riferimento ai benefici previsti in favore delle “vittime del dovere” (artt. 1078 e 1079 t.m., art. 1, commi 563-564, l. 23 dicembre 2005, n. 266) la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
La Corte di cassazione, infatti, ritiene che il legislatore abbia configurato «un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell’art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale» (Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23300; ord. 11 aprile 2018, n. 8982; ord. 21 agosto 2019, n. 21606; Cons. Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1339).
Gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa in ordine alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie di natura oncologica contratte da militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti
Sulle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio – ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – delle patologie di natura oncologica contratte da militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti si sono formati, in seno alla giurisprudenza amministrativa, due diversi orientamenti: un primo orientamento applica anche a tali ipotesi le ordinarie regole in punto di accertamento del nesso causale, senza alcuna semplificazione, né inversione dell’onere della prova; un secondo indirizzo, invece, ritiene che nei predetti casi la dipendenza da causa di servizio debba considerarsi accertata ex lege e possa essere disconosciuta dall’amministrazione solo qualora dimostri l’esistenza di una genesi alternativa della patologia, di carattere extralavorativo.
Più nel dettaglio, il primo orientamento[1] muove dalla lettera delle disposizioni del d.P.R. 461/2001, che subordinano il riconoscimento del nesso di dipendenza (artt. 2 e 3) da causa di servizio e le conseguenti attribuzioni economiche, all’accertamento di un rapporto causale tra il servizio e la patologia sofferta.
L’istituto assume a proprio baricentro la categoria giuridica della causalità, definita dagli artt. 40 e 41 c.p. – che delineano principi applicabili a tutti i rami dell’ordinamento (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2020, n. 122; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2023, n. 674) – in adesione alla teoria condizionalistica (o della c.d. condicio sine qua non, per cui un accadimento può ritenersi causa di altro accadimento solo quando, senza il primo, il secondo non si sarebbe prodotto).
L’accertamento del nesso causale, secondo le più moderne e condivise concezioni (cfr. la nota sentenza Franzese, Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328), implica la necessità di riferirsi a leggi “di copertura”, tratte dalla migliore conoscenza scientifica del momento storico – e aventi lo scopo di selezionare, tra tutti i possibili antecedenti di un evento, quelli dotati di potenziale rilevanza causale – la cui valenza esplicativa deve verificarsi in concreto, con riferimento al singolo, irripetibile, accadimento oggetto del giudizio (che, pur nella sua astratta riconducibilità a quel tipo di antecedente, potrebbe più plausibilmente essere frutto di altro, diverso, decorso causale).
Si tratta, in sostanza, di compiere un giudizio bifasico, prima orientato al rinvenimento di una “causalità generale” (di tipo probabilistico e relativa a “classi” di eventi) attraverso o l’individuazione di una legge scientifica astratta e idonea a fondare un’ipotesi eziologica, poi volto all’accertamento della “causalità individuale”, secondo un criterio di credibilità logico-razionale, fondato sulle evidenze processuali e sulla loro capacità di confermare (o all’opposto confutare) tale ipotesi.
Secondo questo orientamento, dunque, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di qualsiasi patologia, comprese quelle diagnosticate al personale militare che abbia operato in luoghi interessati dalla dispersione di uranio impoverito o nanoparticelle, deve avvenire in adesione al modello concettuale che si è sopra delineato e secondo un criterio di probabilità relativa (altresì detto di “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non”, cfr. Cons Stato sez. II 17 gennaio 2023 n. 608; 3 novembre 2023 n. 9553; 12 aprile 2022 n. 2742; 9 agosto 2021 n. 5816; 3 dicembre 2021 n. 8053), che conduca ad individuare nel servizio la spiegazione eziologica più verosimile dell’infermità.
Pertanto, nel procedimento davanti al Comitato di verifica, come nel successivo, eventuale, giudizio amministrativo non può darsi alcuna presunzione legale o agevolazione probatoria, né per quanto attiene alla dimostrazione di una effettiva, e medicalmente significativa, esposizione diretta ai predetti fattori – da accertarsi in ragione del luogo, del tempo e delle modalità della missione, oltre che delle mansioni svolte dal soggetto – né per quanto attiene alla loro valenza eziopatogenetica rispetto alla patologia insorta – che deve essere anch’essa dimostrata dall’interessato, sulla base di solide e scientificamente accreditate leggi di copertura (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2023, n. 10876; id., sez. II, 11 maggio 2022, n. 718).
Si afferma, pertanto, che «per porre in discussione il parere del C.V. di esclusione della “causalità di servizio” occorre una riconducibilità effettiva e comprovata dell’infermità ,almeno in termini di concausalità, al servizio svolto, poiché l’art. 11 del d.P.R.n. 461/2001 […] non ritiene sufficiente la mera ‘possibile’ valenza patogenetica del servizio prestato, ma impone, di contro, la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia», e che «una significativa esposizione all’uranio impoverito è ipotizzabile per i militari che si trovano nelle immediate vicinanze dell’impatto di un perforatore su un bersaglio corazzato o per coloro che sono incaricati di effettuare perforazioni sul bersaglio colpito o sull’area immediatamente circostante o di procedere alla rimozione, allo stoccaggio e allo smaltimento del bersaglio» (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1259).
A fondare il nesso di dipendenza non è quindi sufficiente il semplice invio in missione nelle aree interessate dall’utilizzo degli agenti di cui trattasi, né il generico riferimento ad una possibile “contaminazione” dei luoghi, ma occorre la prova «dell’effettiva esposizione a fattori di rischio specifici» (Cons. Stato, 1259/2025; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 13 marzo 2023, n. 2598).
Né tantomeno la dimostrazione del nesso causale può essere surrogata dal generico riferimento «a precedenti giurisprudenziali, al fatto notorio dell’avvenuto bombardamento dell’area di missione e a rapporti, studi internazionali e commissioni parlamentari di inchiesta, essendo comunque necessaria l’ulteriore fase di verifica dell’applicabilità delle astratte e generali conclusioni, cui sono pervenuti i rapporti, gli studi, le relazioni e le sentenze richiamate, alla concreta fattispecie per cui è causa mediante la rigorosa dimostrazione dell’esposizione a fattori di rischio specifici e del nesso di causalità o concausalità» (Cons. Stato, 1259/2025).
Per altro, concorrente, profilo, il nesso di dipendenza può essere legittimamente escluso ogniqualvolta l’amministrazione accerti (“a monte” del singolo caso, e cioè sul piano della causalità generale) che non esistono, nella letteratura medica, studi condivisi che correlino l’esposizione ad uranio impoverito e alle nanoparticelle – nelle quantità rinvenute nelle aree interessate del personale militare italiano – al tipo di patologia diagnosticata al militare e manchi, quindi, un’idonea legge di copertura del nesso causale.
Il Consiglio di Stato ha così ritenuto legittima la negazione del nesso di dipendenza da parte del Comitato di verifica allorché, all’esito di approfondimenti istruttori, è stato chiarito che «le conclusioni a cui sono giunti i maggiori studi internazionali registratisi sul tema […] convergono tutte nell’affermare che gli studi epidemiologici del peacekeeping NATO in Bosnia e Kosovo confermano che l’incidenza complessiva del cancro non è aumentata» e che, pertanto, «non è possibile ad oggi trarre conclusioni certe e definitive in merito alla esistenza o meno di una relazione causa/effetto\esistenza di un nesso causale tra presenza sul teatro di guerra, inclusa l’esposizione all’uranio impoverito, ed aumento del rischio di sviluppare un linfoma di Hodgkin; più specificamente, questa relazione non è stata dimostrata, il che, per il mondo scientifico, non equivale a sostenere che non esista, ma che i molti ostacoli delle ricerche condotte non consentono di documentare oggettivamente che ci sia – e, in alcuni studi, addirittura si ipotizza che alcuni elementi indichino che non ci sia, anche se altre potrebbero essere state le cause, quali ad esempio la presenza di un quadro sanitario (infezioni virali) ben più drammatico che in Italia» (Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845).
Analogamente, in altro contenzioso, è stato riconosciuto che «non è possibile ritenere che l’eventuale esposizione a particelle di uranio impoverito o di metalli pesanti sia causa dell’evento rappresentato dalla patologia dalla quale è affetto l’appellante. Ciò in quanto, al di là del richiamo ad un parere di segno opposto del Comitato di verifica su un singolo caso cui fa riferimento l’appellante, secondo la letteratura medica richiamata dall’amministrazione non vi è una probabile correlazione con l’insorgere della malattia» (Cons. Stato, sez. VI, 31 ottobre 2024, n. 8692).
Quanto agli artt. 603 c.m. e 1078 e ss. r.m., essi non sarebbero espressivi di un generalizzato favor ordinamentale per il personale militare esposto all’uranio impoverito o alle nanoparticelle, che possa estendersi all’accertamento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo. La rilevanza impressa dal legislatore alle particolari condizioni operative contemplate dalle citate disposizioni, infatti, «non comporta di per sé una diversa valutazione del parere del Comitato di verifica, sotto il profilo dell’attendibilità del giudizio di esclusione del nesso eziologico, rimanendo la disciplina dell’equo indennizzo improntata alla necessità dell’effettivo accertamento del nesso di causalità, almeno sotto il profilo concausale tra il servizio concretamente prestato e l’insorgenza di una infermità, ancorato a precisi riscontri medico-scientifici e all’esistenza di specifici fatti di servizio» (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6456).
Sicché, anche a riconoscere che la disciplina delle speciali elargizioni alle vittime del dovere possa prescindere dalla rigorosa dimostrazione di un nesso eziologico, ciò assumerebbe rilievo solo ai fini di quelle specifiche indennità – le cui controversie, peraltro, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, inerendo a diritti soggettivi (Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23300; Cons. Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1339) – stante la loro «ontologica differenza» dalla disciplina sull’equo indennizzo ordinario, «che per sua natura richiede la dimostrazione del nesso di causalità con i compiti di servizio» (Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2022, n. 1695).
Deve rilevarsi, peraltro, che anche nelle disposizioni “speciali” di cui agli artt. 1078 e ss. si rinviene un chiaro e inequivoco riferimento alla categoria della causalità e, quindi, alla necessità di un accertamento effettivo del nesso eziologico. Infatti, le speciali elargizioni previste a favore delle vittime dell’uranio impoverito o delle nanoparticelle sono riconosciute solo quando l’esposizione ai predetti elementi (alla stregua di altre “particolari condizioni operative”, contemplate dall’art. 1078) abbia costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso” (art. 1079 t.m.). La disposizione subordina così ogni erogazione ad un accertamento che non diverge, nella sostanza, da quello necessario ai fini dell’equo indennizzo (se non per il fatto di riguardare condizioni di servizio e patologie normativamente “nominate”), come conferma il successivo richiamo, operato dall’art. 1081 t.m., alle “procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461”.
Laddove l’intento legislativo fosse stato rivolto alla previsione di un beneficio pressoché automatico, correlato alla mera concretizzazione di un rischio tipizzato – al fine di evitare, come ritiene l’opposto orientamento giurisprudenziale, che la mancanza di acquisizioni scientifiche consolidate si risolva a danno del privato – non si spiegherebbe il riferimento alla nozione di “causa efficiente e determinante”, né tantomeno l’applicabilità delle procedure di accertamento disciplinate dal d.P.R. 461/2001.
Anche nella legislazione e nella giurisprudenza lavoristica, del resto, è ben delineata la differenza tra i concetti di “causa di servizio” e “occasione di lavoro” (art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224). Solo quest’ultima – ricomprendendo «tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore» (Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2015, n. 6) – può giustificare il riconoscimento di una presunzione probatoria, che esonera il lavoratore dall’onere di dimostrare il nesso causale tra l’ambiente lavorativo e l’infortunio occorso (Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2006, n. 10317). Diversamente, ai fini della domanda di equo indennizzo per “causa di servizio”, l’onere probatorio grava interamente sul lavoratore, il quale deve dimostrare che l’adempimento degli obblighi di servizio sia stato causa, ovvero concausa efficiente o determinante, delle lesioni o infermità lamentate (Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353).
Infine, la presunzione di dipendenza da causa di servizio non può trovare fondamento nel “dovere di protezione” che incombe sul datore di lavoro – compreso quello pubblico – ai sensi dell’art. 2087 c.c. (“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”). Tale disposizione impone di adottare le misure necessarie a prevenire le possibili conseguenze nocive derivanti da fattori di rischio che siano, comunque, riconosciuti come tali sulla base di evidenze scientifiche attendibili e condivise. Pertanto, il fatto che altri contingenti militari abbiano adottato, in relazione all’esposizione ad uranio impoverito o a nanoparticelle, misure di prevenzione diverse e più incisive rispetto a quelle in uso presso il contingente italiano, non vale di per sé a provare la pericolosità dei predetti fattori e il loro costituire causa efficiente rispetto alla patologia oncologica di cui si chieda l’accertamento del nesso di dipendenza dal servizio.
Quanto al secondo orientamento[2] esso si fonda su tre profili argomentativi.
Il primo argomento si basa su considerazioni di carattere generale: in mancanza di una prova scientifica della derivazione da un dato fatto (prova che è condizionata dalle evidenze e dalle conoscenze scientifiche disponibili in quel momento storico) è possibile affermare l’esistenza di un nesso (giuridico) di causalità, non su base deterministica, ma sulla scorta di un giudizio probabilistico. Questo giudizio, alla luce del frequente richiamo nelle sentenze alle circostanze del caso concreto (ad es., la presenza del militare in teatri operativi nei quali si è fatto uso di munizionamento all’uranio impoverito, il rinvenimento, nei campioni istologici, di nano-particelle di metalli pesanti di norma assenti nella generalità della popolazione, il tempo di latenza tra l’esposizione a contaminanti e la manifestazione della patologia etc.), in concreto sembra atteggiarsi in termini di probabilità logica, anziché statistica o numerica, vale a dire di ragionevole probabilità.
D’altronde, si sostiene, anche in materia di risarcimento del danno, quando il militare o i suoi superstiti deducono che la contrazione dell’infermità è riconducibile a un illecito civile dell’Amministrazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ricorre a una regola di giudizio di tipo probabilistico per validare la sussistenza del nesso eziologico, applicando il criterio del “più probabile che non” (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418; sez. II, 9 agosto 2021 n. 5816; sez. II, 12 aprile 2022, n. 2742), il quale non richiede una certezza talora impossibile, ma si sostanzia in una valutazione di prevalenza della possibilità dell’evento sub specie di prevalenza logica (che, nel caso di c.d. multifattorialità nella produzione dell’evento, la giurisprudenza civile di legittimità declina anche in termini di “prevalenza relativa della probabilità”: ex multis, Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13872; sez. III, 5 marzo 2024, n. 5922).
Non si tratta di affievolimento del nesso eziologico, ma dell’individuazione della regula iuris che deve sovrintendere alla soluzione del problema causale attraverso il prudente apprezzamento delle risultanze processuali.
Su questa base, il richiamato indirizzo perviene a riconoscere una correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, tra l’esposizione a determinate sostanze e l’insorgenza di specifiche patologie, ritenendo che la combinazione dei due elementi integri elemento sufficiente (secondo un criterio di probabilità) a configurare il nesso di causalità e quindi a determinare la titolarità, in capo alle vittime, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (ex ceteris, Cons. Stato, sez. II, 7 giugno 2024, n. 5132).
Il secondo argomentato muove dalla considerazione che l’amministrazione della difesa, quale ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall’art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrano ad energie lavorative di terzi di adottare «misure» idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a «tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», in tal modo enucleando un dovere di protezione «che si proietta prismaticamente in tutto l’ordinamento … e, pertanto, trova applicazione anche nel caso del rapporto di impiego o, comunque, di servizio fra il militare e l’amministrazione della difesa» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, nn. 7557, 7560, 7564 e 7578; nonché, tra le altre che vi fanno richiamo, Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6465; sez. II, 3 novembre 2023, n. 9523; sez. II, 29 aprile 2024, n. 3882).
Nelle richiamate pronunce, l’esistenza, nei teatri operativi caratterizzati dall’esposizione fisica (per ingestione o inalazione) a uranio impoverito ovvero metalli pesanti, della necessità di specifiche misure di protezione (le quali, secondo la giurisprudenza civile di legittimità, si distinguono in quelle tassativamente imposte dalla legge, quelle generiche dettate da comune prudenza e quelle ulteriori che si rendano necessarie in concreto: Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14082) è ricondotta al fatto che Forze Armate di Paesi Alleati avevano dotato il proprio personale operativo di dispositivi di protezione individuale e avevano predisposto specifiche procedure volte a minimizzare il rischio da esposizione ad agenti patogeni dispersi nell’ambiente (cfr. anche Cons. Stato, sez. I, 29 aprile 2021, n. 794, per cui «era dovere istituzionale dell’Amministrazione, prima del materiale invio degli uomini in missione, accertarsi presso le parallele strutture della difesa degli Alleati della NATO, fra l’altro, circa il tipo di munizionamento utilizzato durante i pregressi eventi bellici, al fine di individuare l’equipaggiamento più opportuno e predisporre le migliori procedure per l’assolvimento della missione»).
Il richiamo all’inosservanza di obblighi di protezione è evocativo del criterio dello scopo della norma violata, che è criterio normativo sull’esistenza del nesso eziologico (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2024, n. 17171), ragion per cui, nella suddetta prospettiva giurisprudenziale, l’insorgenza della patologia appare implicitamente assunta come concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire (rischio specifico collegato al teatro operativo, per come riconosciuto dalle precauzioni adottate dalle forze armate degli altri Stati), con il corollario che è compito della amministrazione resistente dimostrare che l’evento si sarebbe prodotto anche se avesse tenuto la condotta dovuta.
Un terzo argomento si confronta con il microsistema normativo costituito dall’art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dagli artt. 1078 e 1079, co. 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (in sostituzione dell’abrogato art. 2 d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, attuativo dell’art. 2, commi 78 e 79, della l. 24 dicembre 2007, n. 244), per derivarne la conclusione che lo stesso legislatore ha riconosciuto l’esistenza di un “rischio specifico”, correlato all’impiego in teatri operativi interessati dall’utilizzo di munizioni all’uranio impoverito, per i fini indennitari previsti dalla legislazione vigente, compreso il riconoscimento della causa di servizio (cfr. l’incipit dell’art. 603 cit.) e della speciale elargizione (ex ceteris, Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; sez. II, 22 luglio 2022, n. 6465; sez. II, 4 settembre 2024, n. 7386).
Sotto il profilo probatorio si è affermato, di conseguenza, che «una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei Paesi balcanici e, al rientro da questa, l’insorgere di una patologia tumorale, l’onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si ritiene assolto mediante l’allegazione di essersi trovato ad operare in un territorio in cui erano indubbi la presenza di “inquinanti” metallici e, soprattutto, l’utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito» (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2022, n. 1638), nel qual caso «la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità» (Cons. Stato, sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363).
Ciò tanto più allorché ricorra il dato del rinvenimento, nei tessuti neoplastici, di detriti con presenza di metalli pesanti, accertati mediante esame bioptico, poiché, secondo la stessa giurisprudenza, «a quel punto è onere dell’Amministrazione allegare fatti e circostanze capaci in concreto di dimostrare una diversa matrice, sul piano causale, della presenza dei citati detriti nelle sue cellule tumorali» (ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 1638/2022; sez. I, 7 agosto 2024, n. 1017; sez. II, 15 marzo 2024, n. 2502).
Non si tratta propriamente di un’inversione dell’onere della prova per effetto della creazione pretoria di una presunzione di dipendenza da causa di servizio, ma del riparto tra le parti dell’onere della prova basato sulla scomposizione della fattispecie tra fatti costituivi che, in base al predetto sottosistema normativo, legittimano al beneficio ovvero all’indennità (lo svolgimento di missione in teatro operativo estero caratterizzato da utilizzo di proiettili all’uranio impoverito ed esposizione a nanoparticelle da metalli pesanti; l’insorgenza di una successiva patologia tumorale) ed eccezioni (la sussistenza di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica con riferimento alla patologia tumorale ovvero alla presenza dei suddetti detriti).
Trattasi di una tesi che mutua l’orientamento della Corte di cassazione sull’interpretazione della speciale tutela sancita dall’art. 603 del D.lgs. n. 66/2010, con previsione attuata e specificata con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, agli artt. 1078 e 1079.
Essa, infatti, afferma (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2024 n. 17017): «Nell’interpretazione della descritta normativa di settore … questa Corte ha già affermato che “il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute; il citato dato normativo … richiede che la dispersione nell’ambiente abbia costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni” ed è questo il punto che va correttamente interpretato; non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all’ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l’esposizione all’ambiente descritto dalla norma; i destinatari della tutela, infatti, si trovano all’interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell’accertamento del nesso causale; i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall’esposizione all’uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria” (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n. 7409). Una volta che sia acclarata l’effettiva esposizione all’uranio impoverito o alle altre sostanze nocive, si deve presumere il nesso causale con la patologia tumorale (Cass., sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2996, punti 12, 13, 14 e 15 del Considerato). Incombe sull’amministrazione che neghi il beneficio la prova contraria, che attiene al decorso eziologico alternativo della patologia denunciata (Cass., sez. lav., 10 aprile 2024, n. 9641, in coerenza con la citata ordinanza n. 7409 del 2023)».
[1] Si iscrivono a tale orientamento le seguenti pronunce: Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1501; 17 febbraio 2025, n. 1259; 20 dicembre 2024, n. 10281; 16 dicembre 2024, n. 10098; 2 luglio 2024, n. 5866; 29 gennaio 2024, n. 895; 26 gennaio 2024, n. 845; sez. VI, 31 ottobre 2024, n. 8692; sez. I, parere 13 marzo 2024, n. 291; sez. II, 15 dicembre 2023, n. 10876; 3 novembre 2023, n. 9553; 13 marzo 2023, n. 2598; 6 febbraio 2023, n. 1210; sez. I, 10 luglio 2023, n. 1013; sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8795; 4 ottobre 2023, n. 8478; 22 luglio 2022, n. 6456; 15 luglio 2022, n. 6067; 7 luglio 2022, n. 5662; 12 aprile 2022, n. 2742; 9 marzo 2022, n. 1695; 16 febbraio 2022, n. 1159; 24 gennaio 2022, n. 476; 3 dicembre 2021, n. 8053.
[2] Si iscrivono al secondo orientamento: C.G.A., 5 novembre 2024, n. 872; Cons. Stato, sez. II, 4 settembre 2024, n. 7386; 7 giugno 2024, n. 5132; 23 maggio 2024, n. 4604; 29 aprile 2024, n. 3886; 29 aprile 2024, n. 3882; 15 marzo 2024, n. 2502; sez. I, parere 7 agosto 2024, n. 1017; C.G.A., 19 dicembre 2023, n. 899; sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363; 3 novembre 2023, n. 9544; 3 novembre 2023, n. 9523; 24 ottobre 2022, n. 9054; 8 agosto 2022, n. 6977; 22 luglio 2022, n. 6465; 20 aprile 2022, n. 2991; 7 marzo 2022, n. 1638; sez. I, parere 26 settembre 2022, n. 1544; sez. II, 7 ottobre 2022, n. 6684; 9 agosto 2021, n. 5816; 1° luglio 2021, n. 5013; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; n. 7560 e n. 7564 del 2020; sez. I, pareri 19 maggio 2021, n. 915, 29 aprile 2021, n. 794 e 17 marzo 2021, n. 495.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia