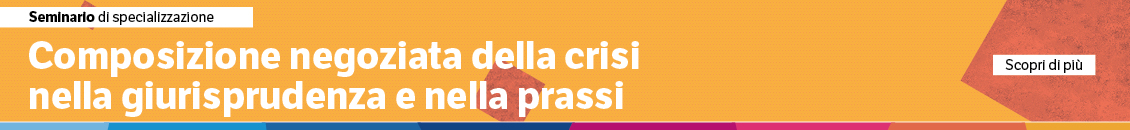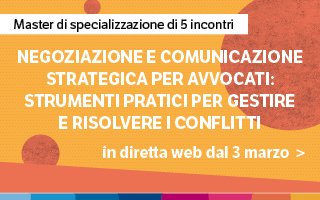Accordi di ristrutturazione inadempiuti e apertura del fallimento: quale credito va ammesso al passivo?
di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sez. I, 15 dicembre 2024, n. 33445 – Pres. M. Cristiano, Rel. C. Crolla
Cassazione Civile, Sez. I, 15 dicembre 2024, n. 33446 – Pres. M. Cristiano, Rel. C. Crolla
Cassazione Civile, Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 – Pres. M. Cristiano, Rel. A. Pozzi
Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Inesecuzione degli accordi – Successivo fallimento – Risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei singoli accordi – Riespansione dell’originaria obbligazione
Massima: “La dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l’attuazione del piano sia resa impossibile per l’intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell’originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.”
Riferimenti normativi: art. 182-bis, comma 4 e 183 legge fallimentare
CASO E QUESTIONE
Chiamata a dirimere la questione se, in caso d’inadempimento degli accordi di ristrutturazione omologati e successiva apertura della procedura di fallimento, il creditore abbia titolo per insinuare al passivo del fallimento il credito originario, ancorché non abbia ottenuto o almeno chiesto la risoluzione dell’accordo prima dell’apertura della procedura, la Corte di Cassazione – con tre pronunzie sostanzialmente coeve –, scartata la possibilità di fare applicazione analogica delle norme in tema di risoluzione del concordato preventivo, ha affermato il principio secondo il quale, in conseguenza dell’apertura della procedura concorsuale liquidatoria, il negozio concluso in sede di accordi deve ritenersi risolto per impossibilità giuridica sopravvenuta, con reviviscenza, quindi, del credito originario; per l’effetto, il creditore è legittimato ad insinuare al passivo il credito originario.
COMMENTO
Inapplicabilità delle norme in tema di risoluzione del concordato preventivo
Esattamente la Corte di Cassazione – dopo aver ricordato che, nella disciplina degli accordi, non si rinviene norma di sorta in ordine alla risoluzione dei negozi conclusi nell’ambito degli accordi – ha affermato, in via preliminare, l’inapplicabilità, per interpretazione analogica, delle norme in tema di risoluzione del concordato preventivo, difettando il requisito dell’eadem ratio: infatti, né, negli accordi può parlarsi di una fase procedimentale successiva all’omologazione (al contrario del concordato, ove vi è una fase esecutiva), né vi sono organi di sorta a controllare il rispetto degli obblighi assunti; di più, proprio per tali caratteristiche, per il singolo creditore sarebbe impossibile controllare l’esecuzione del piano e l’adempimento dei vari, diversi, obblighi.
Di più, mentre l’art. 184 l.fall. determina l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori e, fa sì che, intervenutane la risoluzione, i creditori possano tornare a pretendere i loro crediti per il loro ammontare originario, caducata la falcidia concordataria – negli accordi non vi è alcuna norma simile, avendo l’omologazione la funzione di rendere inapplicabili agli atti esecutivi dell’accordo le norme in tema di revocatoria, determinare l’esenzione da una serie di responsabilità penali e attribuire natura prededucibile ad una serie di crediti.
Inadempimento degli accordi, apertura di procedura liquidatoria e risoluzione dei negozi per impossibilità sopravvenuta
Valicata la premessa circa l’inapplicabilità all’accordo, per analogia, dell’istituto della risoluzione del concordato, le sentenze passano ad osservare come l’apertura della procedura di fallimento determina l’impossibilità di adempiere agli obblighi assunti dall’imprenditore: il suo patrimonio è, per intero, acquisito all’attivo della procedura; egli non può disporne in alcun modo; eventuali pagamenti eseguiti dal fallito sono inefficaci rispetto alla massa dei creditori.
Il fallimento incide così sugli accordi omologati; essi divengono d’impossibile esecuzione; ne segue – e questa è la conclusione dell’iter argomentativo – la risoluzione di diritto per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e la riespansione dell’originaria obbligazione, di talché per i creditori aderenti non è necessario ricorrere agli ordinari strumenti civilistici dell’azione di risoluzione ex art. 1453 ss. c.c.
Tale conclusione troverebbe conferma nell’art. 12, L. n. 3/2012, che, in tema di accordo di composizione della crisi (da sovraindebitamento) stabilisce che la sentenza di fallimento risolva l’accordo.
La Corte osserva, poi, che, a differenza del concordato, la cui risoluzione è soggetta a termini decadenziali, nessun termine è previsto per gli accordi.
Quali diritti per i creditori rimasti insoddisfatti?
La tesi accolta dalla Suprema Corte lascia perplessi.
Intervenuto il decreto di omologazione, l’imprenditore ritorna ad essere soggetto alla disciplina di diritto comune: i creditori riprendono la più totale libertà d’azione[1], nel senso che gli aderenti possono pretendere l’adempimento degli accordi; gli extranei, l’integrale pagamento.
In caso di mancato adempimento degli accordi, è pacifico che gli aderenti possano chiederne la risoluzione[2]; eventualmente, ove siano state inserite negli accordi (ciò che, è ben possibile ed una pattuizione non infrequente), potranno essere fatte valere clausole risolutive espresse[3].
Quanto agli estranei, non pare ch’essi possano chiedere la risoluzione degli accordi; essi non sono parti dei contratti; la loro pretesa all’adempimento degli stessi potrebbe ammettersi solo qualificando gli accordi alla stregua di contratti a favore di terzi, ciò che va, in linea di principio, escluso, fatta salva, s’intende, l’ipotesi che negli accordi siano contenute clausole espresse a favore dei terzi non aderenti[4], nell’ipotesi di accordi ad efficacia estesa.
Quanto ai rimedi apprestati dall’ordinamento, ad avviso di chi scrive è importante distinguere. L’affermazione secondo cui i creditori possono, indiscriminatamente, avvalersi degli istituti di diritto comune, pur diffusa[5], non pare accettabile: se è indiscusso che i creditori possano avvalersi dell’azione di risoluzione[6], non paiono ammissibili le azioni generali di nullità e di annullamento[7] (in particolare, per induzione in errore[8]), da far valere secondo le ordinarie regole di diritto sostanziale e processuale (in particolare in tema di competenza[9]), e che sarebbero da esercitarsi mediante giudizi di cognizione ordinaria[10].
In senso contrario, occorre considerare la peculiare natura che gli accordi assumono in forza dell’omologazione, cui il tribunale perviene non soltanto ad esito di una verifica della sussistenza dei presupposti e della regolarità del procedimento, ma anche di uno scrutinio generale di legalità, in particolare per ciò che attiene alla validità dei negozi (va ricordato che la nullità è sempre rilevabile d’ufficio). Intervenuta l’omologazione, gli accordi cessano di essere semplici negozi di diritto privato[11]; il rimedio avverso l’invalidità degli accordi, in presenza di un difetto genetico degli stessi, è costituito dall’opposizione all’omologazione e dal reclamo alla corte d’appello; esauriti – o non impiegati – i rimedi processuali, non ne sono ammessi altri, di diritto sostanziale, così come non può considerarsi ammessa la dichiarazione di nullità o l’annullamento del contratto preliminare a fronte del cui inadempimento sia stata chiesta e pronunziata sentenza ex art. 2932 c.c. passata in giudicato.
L’azione di risoluzione è invece possibile, come nel caso di sentenze condizionate, in caso d’inadempimento della parte onerata a una certa condotta, se intende conseguire l’effetto della statuizione (ad esempio: sentenza ex art. 2932 c.c. che pronunzia il trasferimento ponendo a carico del promissario acquirente il pagamento della parte residua di prezzo).
Nel caso in cui le parti aderenti abbiano convenuto la novazione delle obbligazioni, occorre verificare se l’accordo raggiunto possa considerarsi avere, in concreto, natura di transazione, e se la pattuizione intervenuta abbia (a norma dell’art. 1230 c.c.) “in modo non equivoco” previsto l’estinzione dell’obbligazione originaria. Se tale patto non sarà stato stipulato, la risoluzione dell’accordo comporterà la reviviscenza del debito originario[12]. Inoltre, l’art. 1976 c.c. fa divieto di risolvere in tal caso la transazione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito[13].
Il fallimento è un caso d’impossibilità sopravvenuta?
Per quanto possa sembrare sorprendente, la ricerca, nei massimari tanto di legittimità che di merito, di sentenze che, in casi in cui si sia in presenza dell’apertura di un fallimento, menzionano l’impossibilità sopravvenuta produce risultati straordinariamente esigui.
Salvo errori, chi scrive ha rinvenuto un unico precedente in cui, in sede fallimentare, risulta essere stata fatta menzione dell’impossibilità sopravvenuta[14] e, tra l’altro, per escluderne la ricorrenza: è stato infatti negato che lo scioglimento del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 81 l.fall., determini gli effetti di cui all’art. 1672 c.c. (impossibilità di esecuzione dell’opera), sulla base del principio che l’impossibilità dev’essere assoluta ed oggettiva, concernente la prestazione in sé e non eventi di natura personale, quale il fallimento dell’appaltatore.
In disparte da tale premessa, occorre tenere per fermo un principio consolidato, ripetutamente affermato dalla dottrina civilistica e non mai contraddetto dalla giurisprudenza[15]: l’impossibilità sopravvenuta, che costituisce il titolo per la risoluzione, ha da avere natura oggettiva, i.e. non deve predicarsi per tale in capo al debitore, ma è un’impossibilità che prescinde dalle condizioni e dalle capacità di chi deve eseguire la prestazione dedotta in contratto; al contempo, l’impossibilità sopravvenuta presenta un requisito di natura soggettiva, i.e. riferibile alla persona del debitore, e tanto nel senso che essa impossibilità non deve essere stata determinata, causata dal debitore stesso, per dolo o anche solo per colpa. Ma non solo: anche l’impossibilità che sia determinata da fattori esterni non libera il debitore se l’evento impeditivo era ragionevolmente prevedibile, sia pure in termini di possibilità[16]; e così, ad esempio, persino nel caso in cui l’impossibilità sia stata determinata dal factum principis[17].
Le vicende personali di chi deve eseguire la prestazione sono irrilevanti così come la mera difficoltà di adempiere per mancanza di liquidità è, pacificamente, irrilevante[18].
Il brocardo genus numquam perit è espressivo di un orientamento tanto risalente quanto radicato nell’insegnamento giurisprudenziale; l’impossibilità sopravvenuta idonea ad estinguere l’obbligazione può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro[19], essendo da considerarsi il denaro alla stregua di una qualsiasi cosa di genere[20].
Così l’intervenuto fallimento dell’appaltatore non configura un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta[21]; del pari, il mancato pagamento di un debito pecuniario non può giustificarsi con l’impotenza economica derivante dall’inadempimento di un terzo[22], posto che non si è, in un caso siffatto, in presenza di un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso e l’impossibilità deve riferirsi alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, non alle concrete possibilità del debitore[23].
In secondo luogo, va pure ricordato che, a determinare la risoluzione del contratto, non è un’impossibilità temporanea che pacificamente determina solo la sospensione dell’esecuzione del contratto, i.e. degli obblighi contrattuali; dev’essere un’impossibilità definitiva perpetua, irreversibile[24]. Ora, in caso di fallimento, anche ammesso che l’apertura della procedura, e la conseguente soggezione del debitore all’espropriazione totale del suo patrimonio, comporti l’impossibilità della prestazione, tale impossibilità non è, di per sé, perpetua, irreversibile; il debitore, chiusa (o revocata) la procedura, torna in bonis e l’impossibilità giuridica di adempiere viene meno.
In terzo luogo, costituisce condizione per l’applicabilità dell’art. 1463 c.c. il presupposto, soggettivo, che l’impossibilità della prestazione non sia stata causata dal debitore stesso, per dolo o per colpa. Così, se il venditore, ricevuto il prezzo, anziché consegnare il dipinto venduto lo distrugge, il contratto non si risolve di certo per impossibilità sopravvenuta.
E non pare diverso il caso del debitore, che, dichiarato fallito, non è più in grado di adempiere perché divenuto insolvente. Ammettiamo senza difficoltà che il debitore possa fallire senza sua colpa; ma non è sempre questa la condizione; anzi, quante procedure si aprono per responsabilità dell’imprenditore o degli amministratori della società che hanno cagionato il dissesto con dolo o anche solo con colpa?
In simili, frequenti, casi, è legittimo dire che si è in presenza di un’impossibilità determinatasi senza che essa sia da imputarsi, nella sua causazione, al debitore?
Direi che più sono i casi in cui si deve ritenere che sussista dolo o colpa del debitore rispetto a quelli in cui la procedura concorsuale è causata da fattori del tutto esterni alla condotta del debitore e del tutto imprevedibili[25].
Inoltre, a ritenere che il fallimento determini l’impossibilità della prestazione, e ne consegua la risoluzione del contratto, ne segue che, ove il creditore si insinui al passivo lamentando l’inadempimento di un contratto (di regola, la stragrande parte delle ipotesi), di diritto il contratto dovrà ritenersi risolto; il credito che il giudice dovrà ammettere al passivo non sarà quello risultato ex actis, ma il controvalore dell’obbligo restitutorio, ciò che – a parte la complessità di dover stimare che cosa valesse, in effetti, sul mercato, la merce venduta, contrattualmente, per un certo prezzo – porta inevitabilmente a possibili sperequazioni.
Infine, non può tacersi un possibile, paradossale, effetto dell’accoglimento della teoria secondo cui l’apertura del fallimento (così come delle altre procedure concorsuali liquidatorie) andrebbe ricompresa tra le cause sopravvenute d’impossibilità della prestazione.
Considerato che, a norma dell’art. 1218 c.c. il debitore non è liberato se non nel caso in cui provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se si definisce l’apertura della procedura come causa d’impossibilità sopravvenuta, allora i crediti concorsuali dovrebbero considerarsi estinti, o inesigibili, stante l’impossibilità di adempierli. E se poi si obietta che una simile considerazione non potrebbe riguardare i crediti già scaduti, per i quali l’inadempimento si è già realizzato[26], resta pur sempre da osservare che, per i crediti non ancora scaduti, la liberazione si attuerebbe subito, per la sopraggiunta impossibilità giuridica di adempiere[27].
Quali tutela per i creditori rimasti insoddisfatti?
Definire, nel sistema concorsuale, l’apertura del fallimento alla stregua di un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione non pare conforme alla lettura che i civilisti offrono dell’art. 1463 c.c. ed è, comunque, una soluzione foriera di possibili esiti contraddittori e persino paradossali.
La tutela delle ragioni degli aderenti nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e il riconoscimento, per intero, del loro credito originario, nel caso in cui il debitore si renda inadempiente agli accordi conclusi, può agevolmente essere affidata ad una panoplia di rimedi, di diritto ordinario: clausole risolutive espresse, azioni di risoluzione per inadempimento, contratti condizionati. Ritenere che, intervenuta la dichiarazione di fallimento, i negozi privatistici conclusi nell’ambito dell’accordo si risolvano per impossibilità sopravvenuta sembra una soluzione né condivisibile, in punto di diritto, né felice, in punto di fatto.
[1] Così, è stato osservato, se, in conseguenza di accadimenti imprevisti o addirittura imprevedibili, si dovesse constatare l’inattuabilità del piano, dovranno ritenersi ammissibili azioni cautelari da parte dei creditori estranei (ma anche da parte di aderenti) i quali prospettino conseguenze imminenti ed irreparabili per le loro ragioni in conseguenza e per l’effetto dell’esecuzione del piano: P. Marano, in Il nuovo fallimento, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 789; cfr. anche S. Ambrosini, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, commentario sistematico diretto da A. Jorio – M. Fabiani, Bologna, 2010, 1137 ss., 1165.
[2] M. Renzulli, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in A. Caiafa – S. Romeo (a cura di), Il fallimento e le altre procedure concorsuali, III, Padova, 2014, 205; G. Racugno, in I presupposti La dichiarazione di fallimento Le soluzioni concordatarie, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore – A. Bassi, coordinato da G. Capo – F. De Santis – B. Meoli, I, Padova, 2010, 556; G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, VIII ed., Milano, 2011, 787. La risoluzione per inadempimento è azione che compete agli aderenti, che lamentino la mancata esecuzione degli accordi: non è pensabile che possano avvalersene gli estranei, che agli accordi sono indifferenti: S. Ambrosini, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, cit., 1167; L. D’Orazio, Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Dal piano al controllo del tribunale, nota a Trib. Roma 20 maggio 2010, in Giur. mer., 2011, 416).
[3] D. Benincasa, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, in A. Caiafa (a cura di), Le procedure concorsuali, II, Padova, 2011, 1419.
[4] E. Capobianco, Gli accordi stragiudiziali per la soluzione delle crisi d’impresa. Profili strutturali e funzionali e conseguenze dell’inadempimento del debitore, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, 323.
[5] G. Racugno, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. comm., 2009, I, 667; V. Tripaldi, in Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2011, 364; M. Galardo, Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell’accordo di ristrutturazione omologato, in Dir. fall., 2011, II, 170.
[6] È possibile ipotizzare la risoluzione degli accordi, con ciò intendendosi la risoluzione di diritto comune dei negozi privatistici conclusi: L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, III ed., Torino, 2008, 342. La risoluzione di tutti gli accordi in tanto potrà considerarsi possibile in quanto l’inadempimento di una delle varie obbligazioni assunte sia rilevante anche per gli altri contratti e per gli altri contraenti, a norma dell’art. 1459 c.c.
[7] E. Frascaroli Santi, Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, Padova, 2016, 816 nega che gli accordi possano essere soggetti alle azioni ordinarie di diritto privato, per la loro natura di procedure concorsuali; M. Galardo, Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell’accordo di ristrutturazione omologato, cit., 170, il quale esclude invece la possibilità della rescissione per lesione, anche alla luce della considerazione che negli accordi sarebbe insito un elemento di alea; e, inoltre, perché, presentando gli accordi una causa simile a quella della transazione, dovrebbe potersi applicare, quanto meno analogicamente, la norma dell’art. 1970 c.c. che non ne consente l’impugnazione per causa di lesione.
[8] Cfr. L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, III ed., Torino, 2008, 344, il quale segnala l’ipotesi della possibile collusione tra il debitore e la maggioranza dei creditori, in danno degli estranei, ipotizzando il rimedio della dichiarazione di fallimento ovvero delle responsabilità civili o penali.
[9] D. Romano, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti alla luce del d.l. n. 83 del 2012, in Giust. civ., 2013, 587; S. Ambrosini, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare, ed. 2010, cit., 1167; V. Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 619.
[10] M. Ferro, Commento all’art. 182 bis, in La legge fallimentare: commentario teorico e pratico, in La legge fallimentare: commentario teorico e pratico, a cura di M. Ferro, III ed., Padova, 2014, 2543; V. Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 619.
[11] E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale, cit., 175, la quale sostiene che gli accordi, una volta omologati, perdono la natura di ordinari contratti di diritto privato e costituiscano il presupposto di un provvedimento giurisdizionale che può essere rimosso soltanto attraverso le impugnazioni.
[12] G. Scarselli, in E. Bertacchini – L. Gualandi – S. Pacchi – G. Pacchi – G. Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, II ed., Milano, 2011, 547.
[13] M. Galardo, Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell’accordo di ristrutturazione omologato, cit., 171.
[14] Trattasi di Cass. Civ. 12 dicembre 2005, n. 1993.
[15] Cfr. Cass. Civ. 4 aprile 2023, n. 9244; Cass. Civ. 22 ottobre 1982, n. 5496.
[16] F. Dalfini, Dell’impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 – 1466), in Commentario Schlesinger, Milano, 2003, 41-42, che richiama, in nota, R. Sacco, in R. Sacco – G. De Nova, in Trattato Sacco, Torino, 1993, II, 652-653, che richiama a sua volta Cass. Civ. 18 aprile 1958, n. 1277 per l’osservazione che, se si considera contrattualmente vincolato e quindi inadempiente chi assume un’obbligazione colpevolmente ignorandone l’impossibilità, sarebbe incoerente non considerare inadempiente anche chi promette una prestazione rispetto alla quale, colpevolmente, egli non sa prevedere la futura impossibilità. Cfr., in precedenza, R. Sacco, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, X, 531.
[17] Cass. Civ. 4 aprile 2023, n. 9244, cit.
[18] Cass. Civ. 15 novembre 2013, n. 25777.
[19] Cass. Civ. 16 marzo 1987, n. 2691.
[20] Ancorché non manchino, in dottrina, opinioni dissenzienti, che si basano sulla considerazione che – venuta meno la convertibilità del denaro – il denaro non è una cosa, ma un mezzo di pagamento, una mera funzione di scambio: “l’oggetto della prestazione pecuniaria venne a consistere non più in un insieme di distinti pezzi monetari, ciascuno dei quali espressione di un determinato valore verificabile e suscettibile di apprensione, bensì in un oggetto di caratteri assai più astratti, cioè in una somma di denaro che rappresentava unicamente l’indicazione numerico-quantitativa di una unità” (B. Inzitari, Le funzioni giuridiche del denaro, in Riv. dir. civ., 1982, I, 698).
[21] Cass. Civ. 12 dicembre 2005, n. 1993, cit.
[22] Cass. Civ. 20 maggio 2004, n. 9645.
[23] Cass. Civ. 9 novembre 1994, n. 9304.
[24] Come, del resto, sancito dall’art. 1258 c.c.: R. Sacco, s.v. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in Dig., IV ed., Sez. civile, XVIII, Torino, 1998, 54. Per la tesi che l’impossibilità deve essere “definitiva”, cfr. anche S. Pagliantini, in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Dei Contratti in generale, ****, Torino, 2011, 546.
[25] Si consideri che, come sopra osservato, anche la prevedibilità dell’impossibilità è ritenuta motivo per escludere l’operatività della risoluzione per impossibilità sopravvenuta (cfr. nt. 20): non è giustificato il contegno della parte che, pur essendo impossibilitata ad adempiere per causa non imputabile, poteva tuttavia prevedere l’impossibilità.
[26] Ma occorre ricordare che l’impossibilità, per essere liberatoria, deve essere permanente.
[27] Ancorché l’apertura della procedura determini la scadenza immediata del credito posteriore (art. 55, comma 2, l.fall.; art. 154, comma 2, CCII); ma il credito viene a scadere in perfetta coincidenza con l’apertura della procedura e, quindi, il debitore, non potendo adempiere, dovrebbe essere liberato.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia