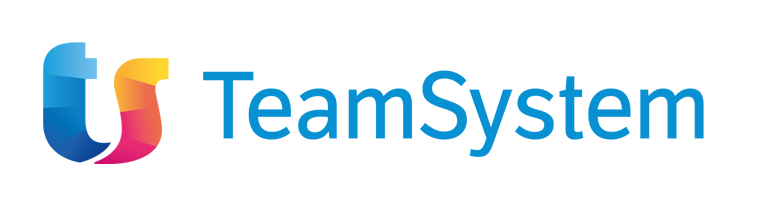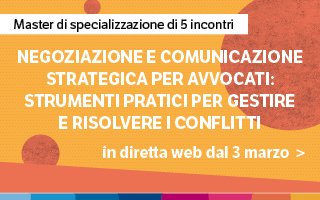Lavoro in presenza, da remoto e ibrido: qual è la scelta migliore?
di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude Scarica in PDFÈ da qualche tempo ormai che mi interrogo su quali siano gli effetti reali sul lavoro in funzione della modalità con cui viene svolto.
Per alcuni anni il lavoro da remoto è stato raccontato come il futuro inevitabile: una trasformazione resa possibile dalla tecnologia, desiderata dai lavoratori e apparentemente priva di controindicazioni strutturali. A distanza di cinque anni, però, quella narrazione mostra crepe evidenti, che molti hanno imparato a riconoscere anche attraverso l’esperienza diretta.
A dare una cornice e molte risposte ai miei dubbi, ci hanno pensato Peter Cappelli e Ranya Nehmeh nel testo “In Praise of the Office. The Limits To Hybrid and Remote Work”, dove il dibattito sul lavoro da remoto è stato analizzato nelle sue tante e diverse componenti:
– l’ambiente fisico dove viene svolto,
– che cosa realmente si perde in funzione delle nuove modalità non in presenza,
– quali sono i modelli migliori e come devono modificarsi le pratiche manageriali per gestirli adeguatamente,
– quanto contano le relazioni interpersonali e come si fa a ricostruirle laddove sono state più o meno lentamente erose e, infine,
– come eventualmente riportare le persone in sede a lavorare limitando i danni derivanti da eventuali malcontenti – e non solo.
Il libro è tanto più prezioso perché evidenzia anche i rischi che derivano da un dibattito spesso alimentato da stereotipi e bias, dati fragili e letture semplificate di studi che si basano su survey rapide, costruite su percezioni individuali e condotte da soggetti con un interesse diretto nell’affermare una tesi piuttosto che un’altra.
I limiti del dibattito non sono tutti qui. Ancora più problematico è il fatto che molte ricerche confondono il lavoro svolto da casa in aggiunta al lavoro in ufficio con il lavoro svolto in sostituzione dell’ufficio. Giusto per amore di chiarezza, nel primo caso la presenza resta l’architrave dell’organizzazione; nel secondo viene meno l’infrastruttura relazionale su cui il lavoro stesso si regge. Le implicazioni organizzative dei due modelli non sono sovrapponibili.
Un altro dei punti che viene ben presentato è che, al contrario di quanto tanti pensano, il nodo centrale non è la produttività individuale.
In molti ruoli, soprattutto quelli di contributo individuale (in cui ricadono molti professionisti), il lavoro a distanza può davvero funzionare e in alcuni casi persino migliorare l’efficienza personale. Il problema emerge altrove: nella cooperazione, nell’apprendimento, nella capacità delle organizzazioni di operare come sistemi complessi.
Il lavoro in presenza ha storicamente prodotto valore non solo attraverso le mansioni formalizzate, ma grazie a una fitta rete di relazioni informali, scambi rapidi, aiuti spontanei e apprendimento per osservazione. Tutti elementi che la distanza tende a indebolire o a far scomparire.
L’ufficio, in questa prospettiva, non è semplicemente un luogo fisico, ma un’infrastruttura sociale. È ciò che rende possibile risolvere problemi senza attivare catene gerarchiche, trasmettere competenze senza procedure formali, costruire fiducia senza doverla codificare. Quando queste dinamiche vengono meno, le organizzazioni diventano più burocratiche, più lente, più frammentate.
Il lavoro continua a essere svolto, ma in modo meno fluido, meno cooperativo, meno adattivo.
Non è un caso che, nella fase iniziale, il lavoro da remoto abbia trovato un forte sostegno anche all’interno delle funzioni finanziarie. Per molti CFO, la riduzione degli spazi e dei costi immobiliari rappresentava un beneficio immediato e misurabile, a fronte di una produttività che, almeno nel breve periodo, sembrava non risentirne.
Il remote work appariva così come una soluzione “win-win”: più flessibilità per i dipendenti, meno costi fissi per le aziende.
Ma come osservano Peter Cappelli e Ranya Nehmeh questa lettura si è rivelata parziale.
I risparmi sugli affitti e sulle sedi, infatti, non incorporavano i costi organizzativi meno visibili, ma non per questo meno reali: l’indebolimento delle relazioni, la perdita di cooperazione spontanea, l’aumento della complessità gestionale.
Costi che non compaiono immediatamente nei bilanci, ma che incidono nel tempo sulla capacità dell’organizzazione di funzionare come tale.
Il lavoro da remoto, in altre parole, non era gratuito: semplicemente, il conto è arrivato dopo.
Anche il lavoro ibrido, spesso presentato come soluzione di compromesso, non è immune da criticità. Se mal progettato, rischia di combinare gli svantaggi di entrambi i modelli: presenze disallineate, uffici semivuoti, occasioni di incontro casuali sempre più rare.
Fenomeni come il coffee badging — ossia la pratica secondo cui la presenza in ufficio si riduce a un adempimento simbolico, spesso limitato a una breve comparsa, finalizzato a “marcare” la presenza più che a partecipare effettivamente ad attività collaborative o relazionali — indica che la questione non è “essere in ufficio”, ma perché e come esserci.
Senza un disegno intenzionale, l’ibrido non ricostruisce né relazioni né cultura e finisce per erodere lentamente entrambe.
Una delle semplificazioni più diffuse nel dibattito pubblico è l’idea che il ritorno in ufficio risponda principalmente a una logica di controllo. Gli autori ribaltano questa lettura: se il problema fosse davvero il controllo dei costi o delle persone, il lavoro da remoto sarebbe una soluzione ideale. Riduce gli spazi, abbassa le spese immobiliari, amplia il bacino di reclutamento.
Il fatto che molte aziende stiano rivedendo le proprie politiche indica invece che ciò che si perde — relazioni, cooperazione, apprendimento informale — ha un valore economico e organizzativo reale, anche se difficilmente misurabile nel breve periodo.
Il libro insiste su un punto spesso trascurato: il lavoro a distanza non è fallito perché “le persone non lavorano”, ma perché le organizzazioni hanno continuato a gestirlo come se fossero ancora tutte insieme in presenza. Onboarding, sviluppo, collaborazione, gestione delle riunioni, costruzione della fiducia: tutto questo richiede pratiche diverse quando la prossimità fisica viene meno.
Senza un cambiamento profondo delle modalità di gestione, il lavoro da remote tende a consumare lentamente il capitale sociale su cui le organizzazioni si reggono.
Tornare in ufficio, però, non è una soluzione semplice né indolore.
Intanto molte aziende non hanno più letteralmente lo spazio fisico per farlo. In secondo luogo, molti lavoratori hanno interiorizzato il remote work come un diritto acquisito, anche quando non è mai stato presentato come tale. Un ritorno imposto rischia di generare risentimento, perdita di fiducia, costi reputazionali e problemi di retention difficili da intercettare nei tradizionali indicatori di performance.
Da qui la conclusione più netta — e più scomoda — del libro: non esiste una soluzione migliore in assoluto. Restare da remoto richiede investimenti manageriali elevati, regole chiare, leadership visibile e una gestione intenzionale delle relazioni. Tornare in ufficio richiede coerenza, spiegazioni, assunzione di responsabilità.
L’ibrido funziona solo se progettato come tale, non come compromesso ambiguo.
Il lavoro del futuro non sarà deciso dagli slogan né dalle preferenze individuali considerate isolatamente. Sarà deciso dalla capacità delle organizzazioni di fare una scelta consapevole, esplicita e coerente, e di assumersene i costi. La vera alternativa non è tra ufficio e remoto, ma tra governare il lavoro o subirne l’erosione silenziosa.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia