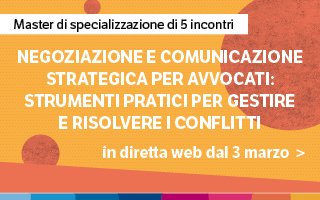Imprecisioni legislative e dommatica processuale: profili processuali del sistema ex art. 8, L. n. 24/2017 in tema di risarcimento del danno da responsabilità medica
di Riccardo Rossi, Avvocato Scarica in PDFRiccardo Rossi
Cass., Sez. III, ord., 5 maggio 2025, n. 11804 Pres. Frasca – Rel. Spaziani
Responsabilità medica – Consulenza tecnica preventiva – Procedimento semplificato di cognizione – Effetti della domanda giudiziale – Competenza – Comparsa di risposta – Eccezione di incompetenza (c.p.c. 5, 18, 19, 20, 38, 39, 281-decies, 281-undecies, 696-bis; L. 24/2017, 8)
[1] Il giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.
CASO
[1] I fatti di causa possono essere compendiati come segue.
Alcuni eredi di un paziente ricoverato, in successione, in due istituti ospedalieri, aprivano verso questi, ritenendoli solidalmente responsabili del decesso del loro congiunto, il procedimento previsto dall’art. 8, L. 24/2017, al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Precisamente, gli eredi rispettavano la condizione di procedibilità proponendo, avverso entrambi gli istituti, il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, adito in forza della regola processuale contenuta nell’art. 33 c.p.c., in quanto solo uno dei convenuti aveva sede in Roma, mentre l’altro a Frascati (Comune ricadente nel distretto del Tribunale di Velletri).
Espletata la consulenza tecnica preventiva senza addivenire a conciliazione, i danneggiati depositavano il ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. (vigente ratione temporis) dinanzi allo stesso Tribunale di Roma, ai sensi dell’art.8, III co., L. n. 24/2017, avanzandolo, tuttavia, nei soli confronti del convenuto con sede legale a Frascati, poiché la consulenza tecnica preventiva aveva escluso la concorrente responsabilità dell’istituto con sede in Roma.
L’ente convenuto nel giudizio di merito, costituitosi, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adìto, in favore di quella del Tribunale di Velletri, luogo nella cui circoscrizione si trova la sua sede legale, nonché luogo in cui si era verificato l’evento dannoso.
Il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione del convenuto dichiarando la propria incompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Velletri, nei cui confronti disponeva la traslatio iudicii.
Avverso l’ordinanza di incompetenza, gli eredi proponevano ricorso per regolamento necessario di competenza, affidandolo a unico motivo.
In breve, i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 8, III co., L. 24/2017, in quanto esso impone di depositare il ricorso afferente al merito (da introdurre, a seguito della Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022 – con il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.) presso lo stesso giudice che ha trattato il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., senza possibilità di radicare detto giudizio avanti a un giudice diverso, nemmeno in un caso come quello in discorso, in cui solo uno degli originari chiamati nell’obbligatorio accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa era stato evocato nella seconda articolazione (i.e., giudizio di merito) del micro-sistema delineato ex art. 8, L. 24/2017.
SOLUZIONE
[1] Pronunciandosi ai sensi dell’art. 363, III co., c.p.c. (considerato che l’eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset dal Tribunale per mancata indicazione di tutti i fori competenti), la Sezione III della Corte di Cassazione ha ritenuto che, relativamente ai giudizi in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il legislatore, con l’art. 8, L. 24/2017, abbia delineato un sistema che vede la compresenza di due procedimenti strutturalmente autonomi, ma funzionalmente collegati (i.e., il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e il successivo giudizio di merito, introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies ss. c.p.c.), e in cui solo il secondo produce in senso proprio i cc.dd. effetti della domanda, i quali, epperò, in conformità al dettato legislativo, pur dommaticamente imperfetto nella sua dizione letterale, retroagiscono al momento della proposizione del primo; ciò porta seco che sarà quest’ultimo il momento determinativo della litispendenza, giurisdizione e competenza, anche se, considerata l’ontologia non unitaria del sistema ex art. 8, L. 24/2017, tali questioni dovranno (e potranno) essere discusse solo in seguito all’introduzione del giudizio di merito.
QUESTIONI
[1] Come noto, la L. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”) ha introdotto nell’ordinamento un’articolata disciplina relativa all’attività sanitaria, in particolare con riguardo ai profili di responsabilità (civile e penale) del medico.
Tra le disposizioni di maggior rilievo figura l’art. 8 della stessa legge, che, relativamente alle controversie civilistiche di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, prevede, ai primi due commi, che chi intenda esercitare la relativa azione, è tenuto a proporre ricorso ex art. 696-bis c.p.c. avanti al giudice competente (comma I), quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento (comma II).
Solo adempiendo tale onere processuale, il danneggiato potrà poi instaurare il giudizio di merito, da introdursi, ai sensi del III comma del medesimo articolo, nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies ss. c.p.c.) e presso il giudice che ha trattato il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. di cui sopra. In tal modo, dispone il dettato legislativo, “gli effetti della domanda sono salvi”.
Su queste basi positive è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza in commento, in ispecie risolvendo due ordini di questioni: il momento determinativo della competenza nel procedimento de quo e il momento in cui tale competenza va verificata.
In via preliminare, la Suprema Corte ha preso posizione sul dibattito relativo alla natura del sistema delineato dall’art. 8, L. 24/2017: passaggio decisivo al fine della soluzione, a valle, delle questioni giuridiche ora accennate.
Premettendo che sarebbe ormai condivisa l’esclusione dal perimetro delle tutele cautelari dell’istituto ex art. 696-bis c.p.c., tanto che la disposizione de qua si apre ammettendone l’operatività anche “al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696” (in dottrina si concorda ampiamente su detta esclusione: v., inter alios, Balena, in Balena – Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 370; Montanari, Brevi note sulla natura giuridica della consulenza tecnica preventiva in funzione di composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.) e sulle relative conseguenze d’ordine applicativo, in Giusto proc. civ., 2012, 701 ss.; Romano, In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e arbitrato, in Giusto proc. civ., 2012, 1121 ss.; isolata la voce di Besso, in Le recenti riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, II, Bologna, 2007, 1328, che pare ritenerne, invece, la natura cautelare), la Corte ha proceduto, allora, alla disamina degli orientamenti che si contendono il campo in materia.
La prima teorica considera la consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c. come strumento avente finalità prettamente conciliativa, nonché deflattiva del contenzioso, e non quale figura particolare di istruzione preventiva (inter alia, v. Trib. Roma, ord. 26 marzo 2015, in Resp. civ. e prev., 2015, IV, 1298 ss.; Trib. Pavia, 14 luglio 2008, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, 45 ss.; Trib. Milano, 17 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 2268 ss.); da ciò deriverebbe, come illustrato dalla Suprema Corte nell’ordinanza in discorso, l’assenza di ogni connessione strutturale tra il relativo procedimento e il giudizio di merito, con la duplice conseguenza, anzitutto, che il giudice competente andrebbe individuato al momento della presentazione della domanda di merito (attivandosi l’art. 5 c.p.c.), e poi che il giudizio di merito sarebbe l’unica sede idonea in cui pronunciare sulla questione di competenza (relegando a un rango di sostanziale inutilità le eventuali pronunce o eccezioni, proposte od omesse, collocabili ai seni dell’ art. 38 c.p.c. sullo sfondo della consulenza tecnica preventiva, in quanto esse non avrebbero alcuna forza vincolante o preclusiva nel successivo giudizio di merito).
La seconda sistemazione concettuale ritiene, invece, che l’istituto in discorso svolgerebbe funzione di istruzione preventiva in posizione comunque strumentale rispetto al successivo giudizio di merito (in part., v., Trib. Como, ord., 11 febbraio 2015, in www.eclegal.it, 2 novembre 2015, con nota di Ferrari, Consulenza tecnica preventiva e conciliabilità della lite; Trib. Torino, 31 marzo 2008, Giur. merito, 2008, 11, 2883), e, pertanto, ne dovrebbe derivare che il procedimento risarcitorio da responsabilità medica ex art. 8 L. 24/2017 concreti un procedimento bifasico, articolato nella fase necessaria e sommaria della consulenza tecnica preventiva e in quella eventuale (là dove non si addivenga a conciliazione) a cognizione piena, con l’ulteriore conseguenza processuale che il giudice dovrebbe verificare la propria competenza già nella prima fase sommaria.
Per vero, con il provvedimento qui commentato, la Suprema Corte ha superato entrambi gli indirizzi ricordati.
In primis, la struttura unitaria bifasica del giudizio risarcitorio ex art. 8 legge n. 24/2017 trova smentita nel fatto che l’epilogo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non conduce ad alcun provvedimento giudiziale, ma alla conciliazione o alla mancata conciliazione delle parti (o, ancora, alla consumazione del procedimento per spirare del termine di sei mesi senza completamento della CTU).
Parimenti, l’impostazione che vede l’ATP conciliativo quale istituto con finalità solo deflattiva, senza alcuna connessione funzionale o strumentale con il successivo accertamento di merito, tradisce il telos dello stesso, in quanto esso deve espletarsi “dinanzi al giudice competente” (art. 8, I co., L. 24/2017) e mira ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di cause caratterizzate da questioni tecniche – quali tipicamente quelle in tema di responsabilità sanitaria –, tanto che ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito (art. 696-bis, V co., c.p.c.).
Per la Suprema Corte, i due procedimenti previsti dall’art. 8, I e III co., L. 24/2017 rimangono strutturalmente autonomi e sono funzionalmente collegati proprio perché il primo si preoccupa di disegnare il quadro probatorio (di natura tecnica) necessario per la pronuncia cui deve mettere capo il secondo: il che spiega altresì il disposto del III co. della disposizione testé citata, là dove afferma che, se entro novanta giorni dal deposito della relazione peritale (senza che sia avvenuta la conciliazione) o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art.696-bis c.p.c. (vanamente decorso senza la conclusione del procedimento), viene depositato il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. presso il giudice che ha trattato la condizione di procedibilità, “gli effetti della domanda sono salvi”.
L’inciso, pur imperfetto nella sua formulazione, considerato che – come visto – non si dà luogo a un procedimento unitario, con la conseguente impossibilità, dunque, di concepire la preesistenza della “domanda giudiziale” rispetto alla fase di merito (così, già, Consolo, Il “tentativo obbligatorio di consulenza-conciliazione” e l’eventuale giudizio di merito: promesse e realtà della elisione della cognizione piena, in Il contenzioso sulla nuova responsabilità sanitaria (prima e durante il processo), Torino, 2018, 36 ss.), è decisivo per stabilire il momento determinativo della litispendenza, della giurisdizione e della competenza.
Infatti, in forza di tale disposto, gli effetti della domanda giudiziale (ovvero del ricorso di merito rivestito delle forme di cui all’art. 281-undecies c.p.c.), pur producendosi con la tempestiva proposizione della medesima, retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., giustificandosi, ciò, proprio in virtù del collegamento funzionale tra i due procedimenti.
Il che, a sua volta, sta a significare che l’istante processualmente rilevante ai fini della litispendenza, giurisdizione e competenza non è quello del deposito del ricorso semplificato di cognizione che introduce il merito, bensì quello del deposito, a monte, del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., giusta l’effetto retroattivo cui dà vita la norma in discorso (per alcuni, la salvezza degli effetti della domanda sarebbe da riconnettere a una sorta di “spirito costituzionale”, considerato che il passaggio ex art. 696-bis c.p.c. è condizione di procedibilità, e dunque percorso obbligato: così Cuomo Ulloa, Risoluzione alternativa delle controversie in materia di responsabilità sanitaria: le novità della legge Gelli – II Parte, in Resp. civ. e prev., 2018, 669 ss.).
La soluzione trova alfine riscontro in due elementi testuali, ovvero il disposto del I co. dell’art. 8, L. 24/2017, che impone di proporre il ricorso di cui all’art. 696-bis c.p.c. “dinanzi al giudice competente”, e quello del III co. della medesima disposizione, ove viene previsto che l’azione di merito debba essere avanzata “presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1”: rimando, questo, che vale a fissare la regola per la quale i presupposti processuali suddetti si cristallizzano al deposito del primo ricorso (i.e. all’ATP conciliativo), con conseguente irrilevanza del successivo mutamento dello stato di fatto e di diritto (tanto che, su queste basi, la Cassazione ha escluso che la chiamata nel giudizio di merito di solo uno dei due convenuti nel procedimento ex 696-bis c.p.c. possa dar vita a un mutamento della competenza già radicata).
Questione concettualmente diversa, ma connessa, è quella attinente alla sede ove procedere alla verifica della competenza del giudice adìto, che la Cassazione tratta e risolve sulla scorta della natura giuridica del procedimento delineato dall’art. 8, L. 24/2017; infatti, non potendosi a questo guardare come a giudizio unitario, seppur bifasico, ma ad un sistema che dà luogo a due procedimenti distinti – pur collegati –, si esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo rispetto a quello a cognizione piena e, anzi, la questione deve discutersi solo in questo secondo, previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta ex art. 281-undecies c.p.c., ove si tratti di questione di competenza territoriale derogabile, oppure con rilievo officioso entro gli ordinari termini preclusivi, nei casi di incompetenza inderogabile.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia