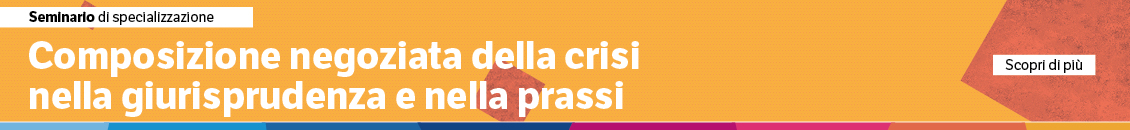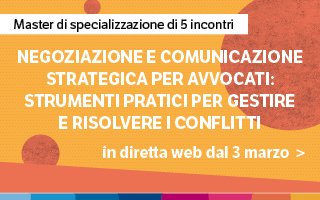Inammissibile il PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) di natura meramente liquidatoria
di Luca Andretto, Avvocato Scarica in PDFTrib. Roma, sez. 14^ civile, 25 marzo 2025, decr. – Pres. Jachia – Rel. Cottone
Parole chiave
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – ammissione – scrutinio – ritualità – vizi di legittimità – continuità aziendale – assenza – liquidazione – cessazione dell’impresa – inammissibilità – integrazioni al piano – nuovi documenti – esclusione
Massime:
[1] A fronte della domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII, il tribunale in sede di ammissione non si limita a un controllo meramente formale del rispetto delle norme procedimentali, ma è tenuto a rilevare eventuali vizi di legittimità tali da rendere sin dall’inizio evidente che il piano proposto non è omologabile.
[2] Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza introdotto dal Legislatore delegato (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, art. 16, con i correttivi poi apportati dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 17) in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1023, la quale impone l’adozione di quadri di ristrutturazione preventiva funzionali alla conservazione dei valori aziendali; questo strumento, pertanto, come conferma un’interpretazione storico-sistematica, presuppone che venga perseguita la continuità aziendale in forma diretta o indiretta, pur compatibile con la cessione degli asset ad essa non funzionali, mentre va escluso che possa assumere una declinazione meramente liquidatoria.
[3] In mancanza delle condizioni per l’ammissione della domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII, non essendo applicabile l’art. 47, comma 4, CCII, deve escludersi che il Tribunale possa concedere un termine per apportare integrazioni al piano o produrre nuovi documenti.
Riferimenti normativi
Costituzione, art. 76; Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 2019/1023, art. 11; Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, artt. 47, 64 bis, 84, 87, 114, 114 bis, 115; D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, art. 16; D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, artt. 17, 56.
CASO
Pochi giorni prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. decreto correttivo ter), una società presentava domanda d’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, riservandosi di presentare la proposta e il piano ai sensi dell’art. 44 CCII. All’esito del termine concesso, formulava domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII (c.d. PRO). Il piano prevedeva la cessazione completa dell’attività d’impresa e il pagamento dei crediti (in via integrale quelli prededucibili o muniti di cause legittime di prelazione, in via parziale quelli chirografari) con le sole risorse liquide disponibili e con quelle derivanti dal realizzo dei crediti e dalla cessione delle altre attività.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, veniva dunque chiamato a svolgere lo scrutinio d’ammissibilità previsto dall’art. 64, comma 4, lett. a), CCII, vagliando la ritualità della proposta e la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Roma dichiara immediatamente l’inammissibilità della domanda di omologazione.
[1] Il via preliminare osserva come, per effetto del decreto correttivo ter (applicabile per quanto di ragione anche agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza pendenti alla data della sua entrata in vigore: cfr. art. 56, comma 4), lo scrutinio d’ammissibilità non si limiti più a un vaglio di “mera” ritualità, ma riguardi tout court la ritualità della proposta. Questo vaglio, quindi, non avrebbe più la circoscritta finalità di far emergere eventuali vizi procedimentali o disomogeneità nel classamento dei creditori, ma si estenderebbe a ogni vizio di legittimità tale da rendere sin dall’inizio evidente che il piano proposto non è omologabile.
[2] La parte centrale del provvedimento è dedicata all’esegesi della normativa e all’esame dei (pochi) precedenti di merito che si erano già espressi nel senso dell’ammissibilità di un PRO avente natura meramente liquidatoria: Trib. Roma, 3 luglio 2024, decr., in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it (emesso dalla medesima sezione, ma in diversa composizione collegiale); e Trib. Milano, 24 ottobre 2024, decr., in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it. Sulla stessa linea viene richiamato anche un altro precedente (Trib. Vicenza, 17 febbraio 2023, decr., in www.eclegal.it), che si era limitato a disporre l’apertura di un PRO in funzione liquidatoria, senza però motivare. Secondo il Tribunale, gli argomenti addotti in questi precedenti non sono decisivi e vengono, anzi, confutati attraverso un’interpretazione storico-sistematica.
Il contesto normativo in cui il nuovo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è stato introdotto dal Legislatore delegato (art. 16, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83) è dato dal recepimento della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 2019/1023 (c.d. direttiva insolvency), finalizzata a “consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte” (considerando 2). Ciò posto, una lettura che ammettesse l’utilizzo del PRO in funzione meramente liquidatoria potrebbe esporre le norme di recepimento a un vizio di costituzionalità per eccesso di delega. Inoltre, la stessa relazione illustrativa del decreto correttivo ter (in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it) chiarisce che “tale strumento ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell’attività sia diretta che indiretta” (premessa all’illustrazione dell’art. 17). Il criterio storico d’interpretazione fa, dunque, emergere il chiaro intento legislativo di circoscrivere l’utilizzo dello strumento in funzione della conservazione quantomeno parziale dei valori aziendali.
Secondo il Tribunale di Roma, questo chiaro intento legislativo troverebbe conferme in ottica sistematica. Non viene ritenuto dirimente, in senso contrario, il rinvio operato dall’art. 64 bis CCII (nei limiti della compatibilità) all’art. 114, che disciplina le attività liquidatorie nel contesto del concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, con espressa esclusione dell’art. 114 bis CCII, che le disciplina nel contesto del concordato in continuità: questa scelta legislativa ben potrebbe stare a significare che, nel PRO con cessione degli asset non funzionali alla continuità, la nomina di uno o più liquidatori debba intendersi doverosa anziché facoltativa. Per analoga ragione, non vengono ritenuti dirimenti i rinvii operati ad altre disposizioni sul concordato preventivo, quali l’art. 87, comma 1, lett. d), e l’art. 115 CCII, certamente compatibili con fattispecie di continuità parziale dell’attività d’impresa; mentre il mancato richiamo all’art. 87, comma 3, CCII viene giustificato con l’estraneità al PRO della disciplina sulla ristrutturazione trasversale, essendo qui l’unanimità delle classi un requisito indispensabile per l’omologazione.
Viene, piuttosto, valorizzato il fatto che l’art. 64 bis CCII, per un verso, non distingue tra valore di liquidazione e valore eccedente, ma si riferisce esclusivamente alla distribuzione del “valore generato dal piano”, così evocando una redditività configurabile solo in presenza di continuità aziendale; per altro verso, al comma 5 si occupa della “gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa”, che viene lasciata all’imprenditore senza alcuna forma di spossessamento, mentre non prende affatto in considerazione l’amministrazione del patrimonio staticamente inteso. Parimenti significativi vengono considerati i richiami: all’art. 91 CCII, che disciplina il procedimento da seguire qualora il piano comprenda un’offerta irrevocabile da parte di soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda o di uno o più rami d’azienda; agli artt. 94 bis e 95 CCII, che disciplinano i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale; e agli artt. 98, 99, 101 e 102 CCII, che nel concordato preventivo disciplinano i finanziamenti finalizzati all’esercizio dell’attività d’impresa. Ulteriore conferma dell’interpretazione proposta viene tratta dal comma 9 bis dell’art. 64 bis CCII, introdotto dal decreto correttivo ter, secondo cui può essere autorizzato dal tribunale il trasferimento dell’azienda o di uno o più rami d’azienda escludendo la responsabilità solidale dell’acquirente.
Infine, un ultimo argomento sistematico viene tratto dal mancato richiamo dell’art. 84, comma 4, CCII, che condiziona la proponibilità del concordato con liquidazione del patrimonio all’apporto di risorse esterne atte ad incrementare almeno del 10% l’attivo disponibile e all’assicurazione di un soddisfacimento dei crediti chirografari in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Secondo il Tribunale di Roma, se si ammettesse un PRO di natura esclusivamente liquidatoria sottratto a tali vincoli, esso “si atteggerebbe ad uno strumento sostanzialmente elusivo”.
[3] Sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale di Roma ritiene evidente che il piano proposto, prefigurante la cessazione completa dell’attività d’impresa, non sia omologabile. A tale giudizio consegue l’immediata dichiarazione d’inammissibilità della domanda di omologazione, senza concessione di un termine alla società per apportare integrazioni o modifiche al piano. La concessione di un termine sarebbe consentita dall’art. 47, comma 4, CCII quando appaia necessario apportare modifiche al piano o produrre ulteriori documenti, onde scongiurare una dichiarazione d’inammissibilità della proposta di concordato preventivo. Questa norma, tuttavia, non è richiamata neanche indirettamente dall’art. 64 bis CCII e viene, perciò, considerata inapplicabile nel contesto dello scrutinio d’ammissibilità del PRO.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
[1] Secondo il Tribunale di Roma, andrebbe esclusa l’ammissibilità della domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ogni qualvolta risulti d’immediata evidenza che esso non è omologabile. L’art. 64 bis, comma 4, CCII, peraltro, limita lo scrutinio d’ammissibilità alla sola ritualità della proposta, oltre che al vaglio di correttezza dei criteri di formazione delle classi. La sussistenza o meno di una continuità aziendale ha, invero, a che fare con la natura del piano, più che con il suo contenuto, e la relativa verifica potrebbe (forse) farsi rientrare in uno scrutinio di ritualità latamente inteso. Ciò che dovrebbe, invece, sfuggire a questo scrutinio sono gli aspetti contenutistici del piano, ivi inclusa la sua fattibilità economica. In un precedente (Trib. Udine, 9 marzo 2023, decr., in www.dirittodellacrisi.it), pur anteriore all’entrata in vigore del decreto correttivo ter, si è in proposito sostenuto che il tribunale debba limitarsi a verificare che, formalmente, la fattibilità sia stata oggetto d’attestazione nella relazione del professionista indipendente richiesta dal comma 3.
A ben vedere, peraltro, esiste un’ipotesi normativamente disciplinata in cui il tribunale è chiamato, già in sede di ammissione, a valutare quantomeno prima facie la fattibilità del piano. Qualora al momento della domanda penda già una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, l’art. 7, comma 2, CCII impone d’esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi, a condizione che il piano proposto non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
[2] Tra gli argomenti addotti dal Tribunale di Roma a supporto dell’interpretazione che esclude l’ammissibilità di un PRO di natura meramente liquidatoria, il più convincente appare quello storico. L’art. 64 bis CCII è stato introdotto dal Legislatore delegato (con l’art. 16, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83) in attuazione di una legge delega (art. 1 e all. A, Legge 22 aprile 2021, n. 53) che si limitava a prevedere il recepimento della direttiva insolvency: esulano certamente dal campo applicativo di quest’ultima gli strumenti con cui l’imprenditore si proponga di liquidare il proprio patrimonio senza conservare, nemmeno in parte od indirettamente, i valori produttivi aziendali. La stessa Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, nella sua relazione sul decreto correttivo ter del 30 gennaio 2025 (in dirittodellacrisi.it) ha, per l’appunto, rilevato che, “In recepimento della direttiva, tale strumento ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell’attività sia diretta che indiretta” (pag. 41).
Deve, allora, convenirsi che non sarebbe stata conforme alla delega l’introduzione di un nuovo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza utilizzabile per scopi estranei a quelli previsti dalla direttiva insolvency. Un’esegesi favorevole ad estenderne l’ambito applicativo declinandolo in funzione di finalità meramente liquidatorie finirebbe col violare la legge delega e, per sua interposizione, l’art. 76 Cost. Del resto, per costante giurisprudenza costituzionale, le norme dettate dal legislatore delegato debbono “interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega” (da ultimo, Corte Cost., 27 marzo 2025, n. 36, in giurcost.org).
[3] Non pare, invece, del tutto condivisibile l’opinione secondo cui, in presenza di vizi idonei a comportare un’immediata declaratoria d’inammissibilità, al tribunale sarebbe preclusa la possibilità di concedere al ricorrente un termine per apportare integrazioni o modifiche al piano. Non si ravvedono ragioni per ritenere incompatibile quantomeno un’applicazione analogica dell’art. 47, comma 4, CCII, anche in considerazione del fatto che il procedimento delineato per l’omologazione del PRO non è rigidamente formalizzato (in questo senso si è espresso Trib. Modena, 26 luglio 2023, decr., in dirittodellacrisi.it). Ad ogni modo, non è preclusa la riproposizione della domanda, una volta emendate le ragioni che avevano condotto all’inammissibilità: riproposizione che può, anzi, essere immediata, non essendo necessario attendere lo spirare del termine per proporre reclamo (come invece previsto per il concordato preventivo dall’art. 47, comma 6, CCII), posto che l’art. 64 bis CCII non contempla questo rimedio qualora la domanda venga dichiarata inammissibile.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia