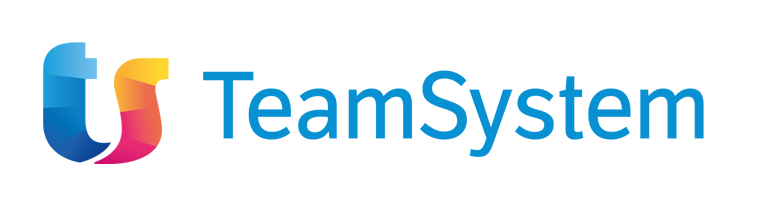La decisione della causa
di Davide Turroni Scarica in PDFIl Focus è dedicato ai principali problemi relativi all’attività decisoria nel processo ordinario di cognizione; con l’avvertenza che molti di questi problemi hanno una vocazione «trasversale», nel senso che interessano l’intera area dei processi destinati a sfociare in decisioni idonee al giudicato.
- Decisione della causa e «potere decisorio»
La decisione della causa, intesa come atto di esercizio del potere decisorio, consiste in una pronuncia idonea al giudicato. Decisione della causa e potere decisorio non sono però termini coestensivi. Il potere decisorio è esercitato anche per la definizione di «unità decidibili» più piccole dell’intera causa (ad esempio di una questione preliminare di merito, come chiarisce l’art. 279, cpv., c.p.c.); o di un giudizio unitario ma relativo a più cause.
A sua volta lo specifico oggetto della decisione determina il vincolo prodotto dal successivo passaggio in giudicato. Così la decisione della causa nel merito è pacificamente idonea al giudicato «pieno», cioè a disciplinare non solo il singolo rapporto deciso ma ogni altro da questo dipendente. Invece la decisione «di rito» ha un effetto conformativo meno intenso: a seconda dei casi, il suo giudicato può arrestarsi al singolo processo, oppure spiegare effetto vincolante in altri giudizi ma – almeno si ritiene generalmente – non in cause relative a rapporti dipendenti.
- Principio di immediatezza e identità del magistrato
La fase decisoria è retta dal principio d’identità del giudice-persona fisica, che è diretta esplicazione del c.d. «principio di immediatezza». Questo canone esige che la decisione sia resa, a pena di nullità della sentenza, dallo stesso magistrato davanti al quale si è tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni. V. ad es., Cass., 14 dicembre 2007, n. 26327; Cass., 9 aprile 2013, n. 8586. La stessa prescrizione si ritiene invece che non operi nelle fasi precedenti, dove la sostituzione del magistrato, pur in violazione dell’art. 174 c.p.c., determinerebbe una mera irregolarità (v. le pronunce appena citate): questa lettura assai tollerante dell’art. 174 c.p.c. riflette la difficoltà pratica di assicurare l’identità dei magistrati durante l’intero corso di processi spesso molto lunghi.
- Tutela del contraddittorio
La decisione della causa deve essere preceduta da una fase in cui le parti precisano le conclusioni e illustrano le loro posizioni in forma scritta o orale, prendono così definitiva posizione sulla materia del contendere. Questa fase è funzionale alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa; per cui dal suo corretto svolgimento dipende la validità della decisione. Parte della giurisprudenza applica un criterio molto selettivo nell’individuare i relativi casi di nullità. La Cassazione, richiamandosi al criterio di «lesività in concreto» delle nullità, ha più volte affermato che la violazione delle norme che disciplinano questa fase non produce necessariamente la nullità della sentenza: questa va dichiarata solo se la parte dimostra che la violazione le ha impedito di svolgere difese idonee a determinare un esito più favorevole della causa (così Cass., 9 aprile 2015, n. 7086, Cass., 23 febbraio 2006, n. 4020, in casi dove il giudice ha emanato la sentenza prima della scadenza dei termini previsti per le comparse conclusionali – e prima del loro deposito. Si tratta però di un orientamento minoritario, perché la giurisprudenza tuttora prevalente considera nulla la sentenza emanata per il solo fatto che il giudice non abbia consentito alla parte di compiere l’attività difensiva propria della fase decisoria: Cass., 5 aprile 2011, n. 4460; Cass., 8 ottobre 2015, n. 20180, con argomentata presa di distanze da Cass., 7086/2015, cit. secondo la quale il criterio di «lesività in concreto», pur operante in generale, non vale quando si impedisca alla parte di compiere attività presidiate da termini perentori.
Va comunque osservato che la nullità, pur sussistente, da sola non basta a procurare una vittoria in sede d’impugnazione. In particolare, nel caso dell’appello l’accertamento del vizio in questione (non rientrando tra i casi di rimessione al primo giudice) non toglie che il giudice ad quem dovrà poi decidere la causa nel merito. Di conseguenza è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, un appello fondato esclusivamente sulla deduzione della nullità in esame, ma privo di censure sul merito del giudizio (v. in tal senso, ad es., 29 settembre 2015, n. 19214). Nel caso di sentenza appellabile, il risultato pratico finisce quindi con l’equivalere in entrambi gli orientamenti; mentre il contrasto interpretativo assume rilevanza pratica nel caso di sentenza non appellabile, o se la violazione si verifica nel giudizio di appello.
- Decisione
Per i giudici collegiali trova integrale applicazione – salve deroghe – lo schema previsto dagli artt. 275 ss. c.p.c. e 119 att. c.p.c. per il giudizio avanti il tribunale collegiale. L’attività «deliberativa» si tiene nella camera di consiglio; è disciplinata in maniera minuziosa dall’art. 276 c.p.c., che regola le modalità di esame e decisione della causa, e dall’art. 119 att. c.p.c., che regola la stesura della sentenza.
La sequenza stabilita nell’art. 276 c.p.c. per decidere le singole questioni e poi il merito non sembra dotata di autonoma rilevanza giuridica. L’eventuale trasgressione nel modus procedendi potrebbe riverberarsi sul contenuto della decisione; ma in questo caso la sentenza è impugnabile per un vizio proprio di essa, non perché il collegio non ha deciso le questioni nell’ordine previsto dal codice.
L’errato recepimento del dispositivo deliberato in camera di consiglio vizia la sentenza. Se il dispositivo firmato dal presidente contrasta con quello riportato nel testo della sentenza, quest’ultima è nulla. Si pone piuttosto il problema per la parte che lo impugna di assolvere il relativo onere della prova; e di coordinare l’impugnazione con la querela di falso, che in linea di principio è necessaria in quanto la censura verte sull’estrinseco di provvedimento che è un atto pubblico (in tal senso v. ad es. Cass., 29 aprile 2010, n. 10282).
La mancata sottoscrizione della sentenza determina la nullità di cui all’art. 161, cpv., c.p.c., che sopravvive all’esaurimento dei mezzi di impugnazione ed è per questo annoverata tra le cause di inesistenza della sentenza. Occorre tuttavia distinguere il caso in cui la firma manca del tutto (nessuno dei tre membri del collegio firma), da quello in cui la firma viene apposta ma non da tutti i magistrati che vi sono tenuti: nel primo caso la sentenza è senz’altro «inesistente» nel senso chiarito. Nel secondo caso, le disposizioni in esame vanno invece coordinate con l’art. 132, u.c., c.p.c., che richiede la firma del solo presidente e del giudice estensore; dunque la sentenza è viziata se manca la loro firma.
Sulla natura del vizio Cass., Sez. un., 20 maggio 2014, n. 11021 ha affermato che l’«inesistenza» ricorre solo se manca la firma di entrambi i magistrati. Se, invece, manca la firma di uno solo dei due, la nullità ricade nella previsione dell’art. 161, comma 1, c.p.c., quindi è sanabile e soggetta alla regola dell’assorbimento nei motivi d’impugnazione. Quest’ultima soluzione vale anche, per espressa previsione dell’art. 50 quater c.p.c., quando la sentenza è firmata dall’unico magistrato nell’erroneo convincimento che la materia sia sottratta al tribunale collegiale.
Quando la legge prevede che il giudice emani il testo integrale della sentenza nella stessa udienza in cui si è tenuta la discussione (nel processo ordinario è il caso disciplinato dall’art. 281 sexies c.p.c.), si è posto il problema della decisione emessa in altra udienza, o comunque in una data successiva alla discussione. Secondo Cass., 30 marzo 2015, n. 6394 questo differimento non è consentito: se il giudice nell’udienza si limita a dare lettura del dispositivo, e soltanto in seguito deposita la sentenza completa della motivazione, la decisione è nulla.
- «Ordinanze decisorie»
Nei procedimenti speciali i provvedimenti decisori assumono più spesso forma di ordinanza o di decreto; ma anche nel processo ordinario non vi è piena corrispondenza tra forma di sentenza e natura decisoria. In particolare non vi è nei provvedimenti che dichiarano l’estinzione (art. 307, ult. comma, c.p.c.) e in quelli sulla competenza (v. art. 42 c.p.c.) che vanno adottati in forma di ordinanza in seguito alla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Quanto ai provvedimenti sull’estinzione è pacifico in giurisprudenza che la declaratoria di estinzione resa in forma di ordinanza competa soltanto al giudice istruttore e sia quindi confinata ai giudizi attribuiti all’organo collegiale. Di conseguenza, il giudice monocratico dovrà sempre dichiarare l’estinzione con sentenza seguendone il relativo iter (Cass., 20 marzo 2013, n. 6880; Cass., 22 ottobre 2002, n. 14889).
La legge 69/ 2009 ha assegnato forma di ordinanza alle pronunce sulla competenza: ciò ha indotto a chiedersi se la forma di ordinanza consenta al giudice (monocratico) di decidere direttamente sulla competenza senza dover aprire la fase decisoria ex art. 189 s. c.p.c. La risposta negativa è venuta da Cass., Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657 (sulla stessa linea v. poi Cass., Sez. un., 29 settembre 2014, n. 20449), la quale ha stabilito che, anche quando la decisione va resa in forma di ordinanza, l’esercizio del potere decisorio è vincolato all’espletamento della fase decisoria e ai relativi incombenti: tuttavia – secondo le Sezioni unite – l’ordinanza emessa de plano è nulla solo se dichiara l’incompetenza; mentre se afferma la competenza è valida ma meramente ordinatoria e inidonea al giudicato formale.
- Decisione emessa per errore in forma diversa dalla sentenza
Può accadere che il giudice decida per errore con ordinanza (o decreto) anziché con sentenza.
Dagli indirizzi giurisprudenziali visti sopra dovrebbero trarsi le seguenti indicazioni:
Se nel pronunciare su questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito l’ordinanza non definisce il giudizio, e non si è previamente svolta la fase decisoria, allora il provvedimento ha natura ordinatoria e non di sentenza. Se invece l’ordinanza, sempre omessa la fase decisoria, decide una vera e propria domanda senza definire il giudizio, il provvedimento deve ritenersi nullo. Se infine si è svolta la fase decisoria, la pronuncia – quale che ne sia il «segno» – non è necessariamente invalida: qui opera qui il criterio c.d. «di prevalenza della sostanza sulla forma» (in ossequio al principio di conservazione) per cui il provvedimento può equivalere a una valida sentenza, a condizione che ne soddisfi i requisiti essenziali – il problema si pone allora nei giudizi collegiali, alla luce di quanto visto sopra.